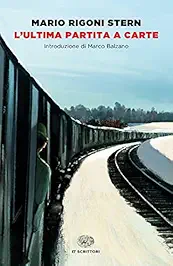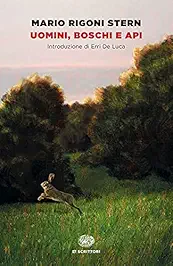.
Cammino lungo il confine estremo di Asiago, dove il brulichio turistico si dissolve come nebbia al sole. I miei passi affondano nella neve fresca, producendo quel suono ovattato, quasi intimo, che trasforma ogni movimento in una confessione sussurrata alla terra. L’aria pungente mi riempie i polmoni, portando con sé il profumo resinoso degli abeti e qualcosa di più antico, di irrisolto.
Qui regna una quiete che inganna. Una calma che non appartiene a questi luoghi per diritto di nascita, ma per conquista sofferta, per cicatrici rimarginate male. Sotto questa coltre candida, il terreno custodisce echi che nessuna stagione riesce a cancellare del tutto. Un secolo fa, queste valli risuonavano di boatos che spaccavano le montagne, di grida che si perdevano nel vento gelido, di giovani corpi che imparavano troppo presto cosa significhi diventare polvere. La Grande Guerra non si limitò a passare di qui: vi mise radici profonde, avvelenando la roccia stessa, trasformando ogni metro quadrato in testimone muto di una violenza che generò altra violenza, in una catena che non conobbe pietà.
Mentre cammino, i pensieri si affollano come corvi su un ramo. Le guerre di oggi – quelle che scorrono sui nostri schermi con la stessa indifferenza di una previsione meteorologica – mi assalgono con la loro presenza assurda, insensata. Viviamo immersi in una superficialità tossica, dove tutto scivola via senza lasciare traccia sulla coscienza collettiva. La follia ha conquistato la scena principale, vestita con abiti sempre nuovi ma animata dallo stesso, ancestrale delirio di dominio. Scenari mutevoli, sempre diversi eppure tragicamente identici: ancora sangue, ancora macerie, ancora madri che piangono figli che non torneranno.
Mi interrogo su quale azione possa ancora avere senso. L’impotenza mi attanaglia come morsa di ghiaccio, e so di non essere solo in questa sensazione di paralisi. Siamo una moltitudine di spettatori incapaci, testimoni disarmati di un presente che sembra sfuggirci tra le dita come sabbia. Un vuoto cresce dentro di me, espandendosi come una macchia d’olio. E con esso, la paura. Non quella viva, pulsante, che ti scuote e ti spinge ad agire. No: questa è una paura sotterranea, strisciante, che corre nelle vene come veleno diluito. Indifferente. Cinica. Una compagna costante di cui quasi non ci si accorge più, tanto si è fatta familiare.
Le voci dei sedicenti potenti raggiungono le mie orecchie come un ronzio lontano, distorto. Individui innamorati solo del proprio riflesso, assetati di visibilità più che di verità, bramosi di un amore sterile, inutile come applausi in una sala vuota. Le loro parole scivolano via dalla mia attenzione, prive di sostanza, mentre i miei piedi continuano a tracciare un percorso che non ho scelto consapevolmente.
Ed eccomi davanti ai cancelli del cimitero. Li varco quasi senza rendermene conto.
Il campo dei defunti si distende come un villaggio silenzioso, sepolto sotto una trapunta immacolata. Le tombe emergono dalla neve come case abbandonate in un paesaggio alpino dimenticato. Cammino tra loro come su un sentiero di montagna, con la stessa reverenza incerta, la stessa consapevolezza di muovermi in un territorio che non mi appartiene del tutto. Attorno a me, il silenzio è così denso che sembra solido, tangibile come le pareti invisibili di rovine che solo io posso percepire.
Una croce si impone allo sguardo, distinguendosi dalla teoria di monumenti che la circondano. Mi avvicino. Sulla lapide, quasi timido nella sua semplicità, emerge il nome: Mario Rigoni Stern. Accanto, quello di sua moglie Anna. Le lettere sono appena leggibili sotto il velo di ghiaccio e neve, come se anche loro partecipassero a quel processo di lenta cancellazione che il tempo infligge a ogni cosa. Ma lì, incongruente e commovente, una rosa metallica resiste. I suoi petali d’acciaio non appassiranno mai, sentinella immobile contro l’oblio.
Ciò che mi colpisce, però, sono i sassi. Decine, forse centinaia di piccole pietre disposte sulla tomba, ognuna portata da mani diverse, in momenti diversi. Un’usanza ebraica che qui assume un significato universale: testimonianza tangibile di presenza, di memoria custodita, di gratitudine che non si rassegna al silenzio. Immagino il fiume di persone che hanno percorso questo cammino prima di me. Lettori che hanno camminato accanto a lui attraverso le pagine del Sergente nella neve, delle sue rievocazioni dell’Altopiano, dei suoi racconti di vita vissuta tra queste montagne. Ognuno di quei sassolini è una conversazione continuata oltre la morte, un grazie sussurrato a un maestro che ha insegnato cosa significhi guardare il mondo senza distogliere lo sguardo.
Mi fermo, e il freddo mi morde le guance. Penso a Mario – permettimi questa confidenza postuma, questo chiamarlo per nome come se ci fossimo conosciuti davvero. Come avrebbe osservato i nostri tempi così disarticolati, così frantumati? Questi giorni in cui la superficialità non è più un difetto ma quasi una virtù proclamata, in cui l’assenza di scrupoli viene scambiata per efficienza, in cui la coscienza – dei sentimenti, della storia, della nostra stessa umanità – si è ridotta a balbettio confuso?
E la memoria. Quella memoria che oggi molti considerano un peso di cui liberarsi, un fardello inutile in un’epoca che guarda solo avanti, senza curarsi di dove poggia i piedi. “Il passato è passato”, ripetono come un mantra ipnotico. Ma Mario sapeva – e lo testimoniava con ogni riga scritta – che senza memoria non esiste futuro degno di questo nome. Solo un eterno presente vuoto, amnesico, condannato a ripetere gli stessi errori in nuove variazioni sempre più tragiche.
Vorrei ascoltarlo ancora. Desidererei, con un’intensità che mi sorprende, sentire nuove parole sgorgare dalla sua penna, dalla sua voce. Quella voce ruvida, segnata dalla vita vissuta sull’Altopiano, tra queste montagne che conosceva come il palmo della propria mano. Una voce che non addolciva la realtà ma la presentava nella sua complessità, con una onestà così rara da risultare quasi sovversiva.
Immagino conversazioni mai avvenute. Gli parlerei di questo nostro smarrimento, dell’egoismo che ci ha catturati con la stessa inesorabilità con cui gli schermi luminosi dei nostri smartphone hanno ipnotizzato le nostre giornate. Siamo diventati prigionieri consenzienti di device che ci promettono connessione e ci consegnano isolamento. Guardiamo il mondo attraverso finestre di vetro che non si possono aprire, toccando con dita nervose superfici fredde invece che la corteccia ruvida di un albero, la mano callosa di un compagno di cammino.
L’egoismo si è fatto cultura dominante, filosofia non dichiarata ma praticata con dedizione feroce. Ognuno rinchiuso nella propria bolla, sordo ai richiami che vengono da fuori, cieco alla sofferenza che non ci riguarda direttamente. E quando pure la vediamo, scorre via come l’ennesima storia su uno schermo, consumata in pochi secondi prima di passare al contenuto successivo.
Un corvo gracchia da un albero vicino, spezzando il silenzio. Il suo richiamo ruvido mi riporta al presente, a questo cimitero innevato dove giacciono storie che meriterebbero di essere ricordate, voci che dovremmo ancora ascoltare.
Poggio anch’io un sassolino sulla tomba di Mario. Un gesto piccolo, forse inutile, eppure necessario. Un modo per dire: ero qui. Ho letto. Ho capito. Non dimentico.
Mentre mi allontano, i miei passi nella neve sembrano più pesanti. Non di stanchezza fisica, ma del peso di domande che non trovano risposta. Come si resiste all’oblio in un’epoca che ha fatto dell’amnesia la propria bandiera? Come si mantiene accesa la fiamma della coscienza quando il vento della superficialità soffia così forte?
Non ho soluzioni da offrire. Solo la certezza che finché qualcuno continuerà a camminare fino a questa tomba, finché sassolini continueranno ad accumularsi come silenziose testimonianze, finché le parole di Mario verranno ancora lette e meditate, allora forse – forse – non tutto è perduto.
La neve ricomincia a cadere, fiocchi leggeri che danzano nell’aria gelida. Coprono lentamente le mie impronte, cancellandole con pazienza infinita. Ma domani, o dopodomani, altre impronte le sostituiranno. Altri viandanti percorreranno questo sentiero, porteranno altri sassi, porranno altre domande al silenzio.
E questo, in fondo, è tutto ciò che possiamo fare: continuare a camminare, continuare a ricordare, continuare a interrogarci. Non arrenderci alla tentazione della dimenticanza, non cedere alla lusinghe della superficialità.
Mario lo sapeva. Ce lo ha insegnato con ogni pagina scritta.
Ora tocca a noi non tradire quell’insegnamento.
Per BookAvenue, Marco Crestani
ultimi articoli dell’autore
alcuni libri di Mario Rigoni Stern
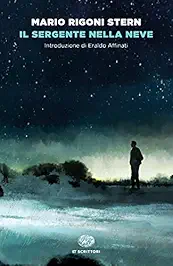



.
.
.
.