.
Volevo un libro per un’ora e mezza di viaggio, qualcosa di breve che mi impedisse di riflettere sui quegli agghiaccianti gemiti degli aerei e che tutti conosciamo. Sono entrata in libreria con il familiare senso di connessione con l’universo che accompagna un acquisto, ma avendo finito da poche ore Follie di Brooklyn (regalo del Direttore), ero in piena crisi d’astinenza da Paul Auster. Mi sono dunque diretta con fare rabdomantico verso il suo scaffale e ho accarezzato i dorsi finché non ho captato una vibrazione libresca. Ho sfilato un libricino dello spessore di una sottiletta, il retro di copertina diceva: “A cavallo dei trent’anni vissi un periodo in cui tutto quello che toccavo si trasformava in un fallimento”. Il messaggio dell’universo a questo punto era piuttosto chiaro, ma è stato il seguito a convincermi che quello sarebbe stato il mio libro da aereo: “Paul Auster indaga negli anni del suo iniziale insuccesso e racconta la sua lotta quotidiana per sbarcare il lunario”.
Premetto che amo le autobiografie, quel genere bistrattato che è l’espressione artistica di una vita. Un’amica editrice mi ripete spesso il suo Credo, frutto di anni di esperienza: in letteratura non è necessario inventare. Paul Auster deve condividerlo, perchè pareva che nel libro sottiletta non si ponesse problemi a descrivere se stesso in quell’epoca – d’oro di fuori e nera di dentro – che sono i vent’anni. Un genio che confessava di essere stato uno sfigato nella New York degli anni Settanta, un mozzo sul ponte di una petroliera, un quasi-attore a Parigi, un quasi-inventore di giocattoli a New York, un giovane padre alle prese con l’affitto e globalmente un fallimento su tutti i fronti. Non ho impiegato più di tre secondi per decidere di comprarlo.
In aereo, l’uomo sul sedile davanti a me ha tentato più volte di attirare la mia attenzione con languidi occhi color miele, ma si è rassegnato quando ho iniziato a scarabocchiare la mia recensione sulla carta d’imbarco. Ero lontano, forse in un labirintico bar di New York verso l’ora di chiusura (tavoli piccoli, mura scarabocchiate, luce fioca). Seduta in penombra con davanti un bicchiere vuoto, ascoltavo un uomo che raccontava una storia intima, la storia del suo Inizio, degli Incontri, dell’Avventura.
America alla fine degli Anni Cinquanta: “il capitalismo americano aveva creato uno dei momenti di massima prosperità nella storia dell’uomo […] e tutta la nazione si era trasformata in un gigantesco spot televisivo […], un invito a danzare intorno all’albero del dollaro finché non si cadeva morti per la semplice frenesia di non essere da meno di tutti gli altri”. Figlio di genitori “medioborghesi”, Paul Auster cresce tra una madre votata al rito del comprare e un padre ossessionato dal risparmio. Il matrimonio dei genitori – come l’unione tra due estremi dell’anima americana – si conclude proprio per l’impossibilità di conciliare due concezioni estreme del denaro. Dunque la sua relazione con i soldi nasce tormentata ma a vent’anni si trasforma inevitabilmente in rifiuto della ricchezza e “dell’opprimente capitalismo americano”.
Un disagio psichico di questa portata sarebbe già sufficiente a precipitarlo a vita nel retrobottega della società, non fosse che Paul Auster si rende conto fin da subito di avere una tara ben più grave: “Fare lo scrittore non è «una scelta di carriera», come fare il medico o il poliziotto. Più che sceglierlo, ne vieni scelto, e una volta che hai constatato che non sei adatto a fare nient’altro, ti devi preparare a percorrere per il resto della vita una strada lunga e difficile”.
Tuttavia – per il godimento del lettore – si tratta di una strada costellata di incontri mirabolanti ed esperienze straordinarie, perle che emergono da quello scenario che Philip Roth ha reso indelebile in Pastorale Americana. È il 1969 quando Paul Auster osserva i manifesti dei dieci maggiori ricercati dell’F.B.I. e scopre che sette erano suoi compagni di college. Il dissenso, la Guerra del Vietnam, il terrorismo di un manipolo di studenti chiamati “Weather Underground”, le Pantere Nere: tutto scorre silente sullo sfondo di una titanica lotta interiore fra il desiderio per la scrittura e la necessità di un’occupazione stabile.
Paul Auster é attirato da quelle “latrine del mondo” dove la sua educazione scorre in “rivoli inaspettati” di cui la sua arte si nutre, ma nella ricerca di un impiego fisso finisce dritto dritto nel ventre della Bestia. È poco più che ventenne quando si imbarca su una petroliera della Esso: “ero uno fra milioni, un insetto che sgobbava al fianco di innumerevoli altri insetti, e ogni mansione che eseguivo rientrava nel grande, opprimente sistema del capitalismo americano”. Ed è questa esperienza a portarlo nel cuore del sabba di morte del dio petrolio: “non scorderò mai i pesci, le centinaia di pesci morti iridescenti che galleggiavano sull’acqua fetida, satura di petrolio intorno ai moli delle raffinerie. […] La bruttezza era così universale, così profondamente insita nell’accumulo di denaro, e nel potere conferito dal denaro a chi se ne arricchiva – al punto di deturpare il paesaggio, di sconvolgere il mondo naturale – che a denti stretti cominciai a rispettarla. Vai a fondo nelle cose, mi dicevo, e l’aspetto del mondo è questo. Per male che se ne potesse pensare, quella bruttezza era la verità”.
Ma tra le pagine di Sbarcare il lunario abita anche il ricordo di personaggi che si innalzano davvero a tragici Don Chisciotte in lotta contro i mastodontici mulini del dollaro. Fra tutti spicca il leggendario romanziere dimenticato H. L. Humes – alias Doc – che elargisce ai passanti biglietti da cinquanta fino a dilapidare la sua intera eredità. “Non erano semplici doni”, scrive Auster, “ma armi per un mondo migliore. Con la sua prodigalità voleva dare l’esempio, mostrare che ci si può sottrarre al maleficio, che si può spezzare l’incantesimo gettato dal denaro sulle nostre anime”.
E poi uno straordinario Amarcord di personaggi e luoghi affiorano dalle pagine come puntelli su una geografia dell’anima. Teddy e Casey, amici per la pelle in cui “sopravviveva lo spirito di Laurel e Hardy” con la differenza che “facevano parte del mondo reale ed eseguivano il numero sul palcoscenico della vita”. Poi gli infiniti lavori saltuari, fino a salire “su un podio all’aperto con Jean Genet e tradurre il discorso in difesa delle Pantere Nere”. E Parigi, e lo strano impresario che lo porta a sfiorare il mondo del cinema. Poi “quello strano individuo, il più fenomenale fra i falliti, il solo e unico Joe Reilly”. Infine quella voce, la ragazza dell’Esercito della Salvezza che a un angolo di strada “cantava sul far della sera mentre la gente tornava stancamente dal lavoro – un canto triste, lamentoso, sulle miserie umane e le meraviglie di Dio”.
“Quella voce”, scrive Paul Auster, “la porto ancora dentro, una voce cristallina da far crollare in pianto anche il cuore più duro, e la cosa incredibile è che nessuno le prestava attenzione”. Ed é forse quella voce – mi dico – che continuo a sentire da quando sono scesa dall’aereo. E dev’essere sempre quella voce ad avermi guidato, oggi pomeriggio, alla libreria inglese di Francoforte.
Volevo altro Paul Auster, altra Vita.
.
per BookAvenue, Silvia Belcastro
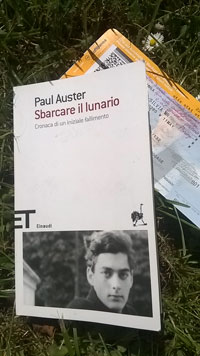
Il libro:
Paul Auster,
Sbarcare il lunario,
Einaudi,
ed,2010 pp.117
.
.
altri articoli dell’autore
ndr. questo articolo è stato pubblicato il 15 maggio 2015 per il reading room







