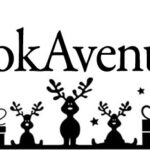.
Prima Puntata. (seconda, terza)
Come studiosa e lettrice di letteratura, non ho mai visto i libri così separati dal presente o dalle nostre esperienze soggettive. I libri sono personali. L’intimità soggettiva che emerge dalla lettura è tale che i libri diventano parte di ciò che siamo. Quando rientriamo nello stesso libro, riaffioriamo ai noi stessi precedenti che preservano aspetti di ciò che eravamo.
Come studiosa di letteratura, mi ritrovo inevitabilmente a rientrare negli stessi universi letterari più e più volte, con visite di me stessa del passato a margine, sconcertanti nel loro entusiasmo, nella loro intuizione e nell’occasionale sottolineatura superficiale. Per quanto storicamente lontana dal presente, la letteratura parla direttamente alle nostre attuali realtà personali e geopolitiche. Come persona che non tiene un diario, trovo alcune delle mie opinioni personali più acute ai margini dei libri. Vedo il mio passato commemorato in quei margini, mentre le mie realtà rispondono al testo, confrontando l’urgenza del passato con l’urgenza a volte più forte del presente.
Per me, l’attuale violenza russa in Ucraina ulula forte alle pagine e ai margini di Fëdor Dostoevskij fin dal 24 febbraio 2022. Molte delle sue parole denunciano le sue altre parole, in una straziante cacofonia di voci che non accenna a giungere a una riconciliazione. Alcuni passaggi di Dostoevskij possono sembrare consacrare il nazionalismo e la “grandezza” russi, promuovendo i perniciosi programmi globali e politici del governo russo, mentre altri ci scuotono moralmente al punto da farci rifuggire da tutto ciò che è accaduto e continua ad accadere in Ucraina.
Leggendo Dostoevskij ora, mi ritrovo furiosa per alcune parti dei suoi scritti, elaborando il mondo attraverso Dostoevskij e, allo stesso tempo, consapevole che molte delle sue idee sono state rese complici di ciò che sta accadendo. E questo, mentre mi confronto direttamente con l’io che leggevo Dostoevskij dieci o vent’anni fa, l’io che è diventato un individuo vent’anni fa, Dostoevskij era al centro del mio percorso di studi umanistici. Ho raccontato e scritto principalmente di Tolstoj nella mia carriera di insegnante, ma studiare Dostoevskij è stato il modo in cui ho imparato a diventare una studiosa. Dostoevskij mi ha aiutata a essere quella versione di me stessa che non sarebbe completa senza la mia identità accademica; ha contribuito a coltivare quella versione di me che ora a volte si ritrae di fronte al bagaglio culturale incarnato nel culto del “grande scrittore russo”.
Se le occasionali contraddizioni di questa mia narrazione sembrano uscite da Dostoevskij, non è del tutto casuale, perché pochi scrittori hanno la capacità di catturare la paradossale complessità delle nostre reazioni di lettori e spesso delle nostre reazioni a noi stessi. Mi aggrappo a Dostoevskij per la complessità, la polivalenza e la polifonia, la contraddittorietà, l’occultamento e la sovraesposizione, il disordine soggettivo incarnato, l’apertura a interpretazioni errate – le tante cose umane che così spesso resistono alla coerente lucidità dell’ideologia e dei sistemi politici della propaganda.
Dostoevskij scrive come uno scrittore che ha da tempo smesso di credere nei sistemi, per il quale non esiste alcuna norma di legge al di fuori della nostra coscienza morale che possa giudicare le nostre esperienze – è per questo che gran parte di ciò che dice è aperto all’interpretazione, perché gran parte dell’esperienza di lettura di Dostoevskij è legata alla nostra lettura e alla creazione di significato, piuttosto che all’autore che conduce questo significato in una forma compiuta. Dostoevskij vede esseri umani che cercano di dare un senso a un mondo imperfetto, da soli o semplicemente al seguito gli uni degli altri. Ci lascia soli a dare un senso ai suoi libri, e nulla è cambiato ora, se non il fatto che ci sono più significati con cui confrontarci. Grazie a Dostoevskij.
“Il nazionalismo messianico di Dostoevskij è la caratteristica più controversa della sua prospettiva intellettuale“, scrive il critico e filosofo James Scanlan in vecchio libro di studi: Dostoevskij il pensatore (2002). Scanlan affronta ampiamente le idee di Dostoevskij sul nazionalismo messianico russo per mostrare la progressione attraverso la quale Dostoevskij passò dall’abbracciare un nazionalismo neutrale, permeato dalla consapevolezza delle peculiarità delle diverse culture, a una variante più sciovinista del nazionalismo, in cui immaginava la Russia come superiore e non solo distinta dalle altre culture. Le prime teorie di Dostoevskij sulla terra natia (pochvenichestvo o la più conosciuta Ròdina) si concentravano su come la Russia fosse distintamente russa, e su come le idee e le istituzioni occidentali non potessero prosperare al suo interno. “C’è nella nostra terra qualcosa di nostro, qualcosa di nativo, che è radicato nei fondamenti naturali e ancestrali del carattere e dei costumi russi; che la salvezza risiede nella terra e nel popolo… Gli ideali occidentali non potranno mai soddisfarci completamente“, scrive Dostoevskij in un articolo degli anni ’60 dell’Ottocento. Sebbene nel loro contesto queste idee fossero abbastanza benigne e alimentate dallo spirito nazionalista del primo movimento romantico, tali parole sono diventate molto più problematiche rispetto allo spettro inquietante dei nazionalismi violenti del nostro presente. Parole che un tempo significavano una cosa ora significano qualcosa di completamente diverso. Le idee di Dostoevskij sul nazionalismo, la sua “idea russa”, costituiscono uno spettro. A un certo punto, egli passa dall’ideologia della patria a una forma di nazionalismo più ampia e aggressiva, che apparentemente colloca la Russia in un ruolo di salvatrice per le altre nazioni. Una fede dunque, quella di Dostoevskij, nella capacità russa di generare amore fraterno e universalità.
Valeria Belledi.
fine 1a puntata >
la seconda puntata sarà pubblicata il 9 agosto.
ultimi articoli