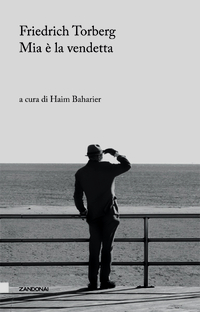Riproponiamo alla lettura, l’articolo di Alen Loreti sul libro di Friedric Torberg.
“Qual è il libro più bello che hai letto quest’anno?” Alla domanda di una mia amica, professionista del campo editoriale e forte lettrice ─ capace di doppiare con facilità la cinquantina di volumi letti dal sottoscritto in un anno ─ non ho manifestato incertezze: “Un libro di Torberg”, ho risposto. E lei: “Ma chi, l’ebreo che fuggì alle persecuzioni e finì in California?”. Sì, proprio lui, proprio quel Friedrich Torberg ─ pseudonimo di Friedrich Ephrain Kantor ─ che nel 1943 pubblicò a Los Angeles un piccolo capolavoro finalmente tradotto in italiano da Martino Tranker e proposto dalla casa editrice Zandonai con il titolo Mia è la vendetta.
Domande. È un libro tremendo e straordinario, ben poco adatto al clima natalizio, ma voglio parlarne ora, per evitare che venga assorbito dalle decine e decine di titoli che tra meno di un mese usciranno in occasione della Giornata della Memoria. Se possibile, questo libro va letto prima. Perché prima di altri ha messo in luce i quesiti che i sopravvisuti alla soluzione finale avrebbero dovuto affrontare: perché Dio ─ parola che nella lingua ebraica non esiste, perché esistono solo attributi del divino ─ perché ha potuto permettere l’orrore della Shoah?
Il silenzio di Dio, così alcuni reduci chiamano lo sterminio del popolo ebraico, come si lega alle scelte dell’uomo? Dove abita la responsabilità divina? E quella di ogni singolo ebreo? Se la narrazione è l’unico modo per aprirsi un varco attraverso i determinismi sociali e quelli della natura, come spiega Haim Baharier nell’ottima postfazione, cioè se è un modo per smontare la logica che conduce al campo di sterminio, allora il romanzo di Torberg è un cammino di libertà, “perché se esiste una vendetta divina non ci riguarda, noi non vendichiamo. Noi ci difendiamo legittimamente.”
 L’autore. Ma chi è Friedrich Torberg? Classe 1908, padre boemo, madre ungherese, ebrei di Praga trasferiti a Vienna, all’alba delle prime persecuzioni scappa in Svizzera; con lo scoppio della guerra si unisce come volontario all’armata cecoslovacca per liberare la Francia; dopo l’occupazione di Parigi (14 giugno 1940) si guadagna l’uscita dall’Europa grazie alle sue posizioni antinaziste; sbarca negli Stati Uniti dove lavora come giornalista e sceneggiatore (Time Magazine e Warner Bros.). Tutto sembra scampato, ma non è così. Nel 1941 madre e sorella vengono catturate, deportate e soffocate nelle camere a gas di Auschwitz. È il destino dei suoi famigliari dunque a indurlo a scrivere qualcosa su ciò che sta accadendo. Studia, si documenta, s’informa sui primi campi di concentramento già presenti dal 1933, raccoglie informazioni da chi arriva dall’Europa. In un mondo in guerra che ancora non conosce le proporzioni spaventose della Endlösung der Judenfrage, Torberg scrive una storia capace di focalizzare nel destino di un uomo l’enorme peso morale di una umanità sconvolta e smarrita che, lontana dal fideismo, non ha più strumenti per interpretare le proprie aberranti azioni criminali. “Un granello di sabbia in una clessidra, in apparenza il racconto di Torberg. È però quel granello che smuove la sabbia ferma nella strozzatura e libera tutto ciò che sopra stagnava, tutto ciò che si era già detto e scritto sul libero arbitrio dell’uomo”, spiega Baharier nella postfazione.
L’autore. Ma chi è Friedrich Torberg? Classe 1908, padre boemo, madre ungherese, ebrei di Praga trasferiti a Vienna, all’alba delle prime persecuzioni scappa in Svizzera; con lo scoppio della guerra si unisce come volontario all’armata cecoslovacca per liberare la Francia; dopo l’occupazione di Parigi (14 giugno 1940) si guadagna l’uscita dall’Europa grazie alle sue posizioni antinaziste; sbarca negli Stati Uniti dove lavora come giornalista e sceneggiatore (Time Magazine e Warner Bros.). Tutto sembra scampato, ma non è così. Nel 1941 madre e sorella vengono catturate, deportate e soffocate nelle camere a gas di Auschwitz. È il destino dei suoi famigliari dunque a indurlo a scrivere qualcosa su ciò che sta accadendo. Studia, si documenta, s’informa sui primi campi di concentramento già presenti dal 1933, raccoglie informazioni da chi arriva dall’Europa. In un mondo in guerra che ancora non conosce le proporzioni spaventose della Endlösung der Judenfrage, Torberg scrive una storia capace di focalizzare nel destino di un uomo l’enorme peso morale di una umanità sconvolta e smarrita che, lontana dal fideismo, non ha più strumenti per interpretare le proprie aberranti azioni criminali. “Un granello di sabbia in una clessidra, in apparenza il racconto di Torberg. È però quel granello che smuove la sabbia ferma nella strozzatura e libera tutto ciò che sopra stagnava, tutto ciò che si era già detto e scritto sul libero arbitrio dell’uomo”, spiega Baharier nella postfazione.
La storia (dall’ottima bandella, N.d.A.). In una giornata di novembre del 1940, sul molo del New Jersey, un uomo attende i suoi amici provenienti dall’Europa. Più volte la sua attenzione è attratta dalla figura scarna e curva di uno straniero che si aggira inquieto nella sala arrivi e sul pontile. Quando gli chiede chi stia aspettando, lo straniero risponde che sono tanti, settantacinque, quelli che dovrebbero arrivare, eppure non giunge mai nessuno. Lo straniero è tormentato dal ricordo degli eventi accaduti poco tempo prima in un lager nazista sul confine olandese, dal quale è fuggito. Invitato ad accomodarsi in un bar decide di raccontare la sua storia. Parla così del comandante del campo Wagenseil che sceglie una vittima dopo l’altra tra gli ottanta ebrei lì rinchiusi, e li tortura nel corpo e nell’anima al punto che essi decidono di suicidarsi. Nella baracca in cui i prigionieri si ritrovano ammassati come bestie si accende il dibattito fra due gruppi: gli uni ─ rappresentati dal candidato rabbino Joseph Aschkenasy ─ ritengono di dover andare incontro al proprio ineluttabile destino lasciando la vendetta a Dio, gli altri pensano invece sia opportuno reagire. Perché mai non aggredire l’aguzzino durante i suoi interrogatori e, dato che non c’è via di scampo, non trascinare anche lui nella morte? In che misura rivendicare una resistenza ebraica e la legittima difesa?
Gli strumenti… A chi temesse di essere sprovveduto di fronte a temi così impegnativi ecco l’aiuto prezioso della nota al testo di Giusy Drago, che ricostruisce la storia dell’opera e la biografia dell’autore, e la postfazione di Haim Baharier, psicanalista tra i massimi esperti contemporanei di ermeneutica biblica. Sono due appoggi sicuri che permettono al lettore di cogliere in profondità la capacità visionaria, e per questo cristallina, del romanzo di Torberg. Boris Pahor in Necropoli parlando della lapidi in memoria delle vittime scrive che “più che un atto pietoso, quella lastra di pietra che collochiamo sul tumulo rappresenta un tentativo di preservarci dalla dimenticanza, dalla pochezza della nostra capacità di trattenere i ricordi, dall’instabilità della nostra fluida coscienza.” Si potrebbe dire lo stesso di questa opera dell’autore austriaco.
 …per capire. Ho in mente il lungo dialogo tra Primo Levi e Ferdinando Camon pubblicato nel 1987 da Nord-Est (Autoritratto di Primo Levi, edito poi da Garzanti e attualmente da Guanda) e c’è un passaggio in cui lo scrittore veneto dice: “Ci sono dolori che rendono più buoni, e dolori che rendono più cattivi. Probabilmente quelli vissuti in condizione di impotenza rendono più buoni.” Alle parole di Camon Levi ribatte con sicurezza: “Non credo di essere diventato più buono. Ho capito alcune cose, ma non sono diventato più buono.” È lo stesso effetto che si ottiene dopo aver letto Mia è la vendetta. Non si diventa più buoni, ma si capiscono alcune cose. E Dio solo sa quanto sia vitale per l’uomo, credente o meno, capire. Capire almeno un po’.
…per capire. Ho in mente il lungo dialogo tra Primo Levi e Ferdinando Camon pubblicato nel 1987 da Nord-Est (Autoritratto di Primo Levi, edito poi da Garzanti e attualmente da Guanda) e c’è un passaggio in cui lo scrittore veneto dice: “Ci sono dolori che rendono più buoni, e dolori che rendono più cattivi. Probabilmente quelli vissuti in condizione di impotenza rendono più buoni.” Alle parole di Camon Levi ribatte con sicurezza: “Non credo di essere diventato più buono. Ho capito alcune cose, ma non sono diventato più buono.” È lo stesso effetto che si ottiene dopo aver letto Mia è la vendetta. Non si diventa più buoni, ma si capiscono alcune cose. E Dio solo sa quanto sia vitale per l’uomo, credente o meno, capire. Capire almeno un po’.
Àlen Loreti per BookAvenue