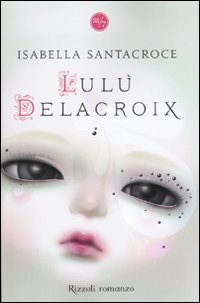Chiedo scusa se la recensione del libro in questione non vi arriva dritto sulle scrivanie allo scoccare del mese, ma vorrei vedere voi alle prese con 468 (quattrocentosessantotto) pagine del nuovo romanzo di Isabella Santacroce. Romanzo che non coincide col suo libro più brutto, ma si tratta senza ombra di dubbio del più inutilmente lungo che sia stato mai scritto. Ho sempre trovato squallido ragionare coi libri in termini di mole, ho sempre condannato chi dichiarava di avere problemi di numeri di pagine, ma un conto sono I Fratelli Karamazov e un altro è Lulù Delacroix.
La storia riguarda una bambina mostruosa, Lulù per l’appunto, che ha la sfortuna di nascere a Perfect City, città dove tutti, a scanso di equivoci, sono perfetti. Lulù non può uscire di casa perché la sua famiglia si vergogna di lei e trascorre così l’infanzia nelle mura di casa tra i dispetti delle sorelle e le sue amiche immaginarie, che non sono proiezioni infantili o eroine della tv ma nientepopodimeno che Emily Dickinson (cui è dedicato il libro). Nonostante la sua bruttezza ma grazie alla sua purezza, Lulù riuscirà a fronteggiare i mille ostacoli che troverà nel Regno del Mistero e a vincere la sua battaglia, ossia sconfiggere i pregiudizi e imporre l’accettazione.
Dal pulp versione ketchup di Destroy, la Santacroce passa in questo romanzo a una scrittura che ne fa una sorta di Liala allo scquacquarone – “Di una musica dolce la presenza s’avvertiva tra le foglie di un bosco rosa confetto che la loro fuga d’improvviso raccolse, quasi fosse nascosta tra l’edera che i tronchi delle piante salendo copriva, raggiungendo le loro chiome intrecciate, a creare una lunga caverna che cavalcando nobili cervi Lulù e Mimì attraversavano” – con un’aggiunta, da metà libro in poi, di personaggi fantastici alla Alice nel paese delle Meraviglie. Nell’andare incontro al suo proprio destino, Lulù incontra nell’ordine: Tommy, Stoppy, Drollo La Pianta, Ghigliottinato D’Orso, i Pippidolli Salterini, l’Alato Tavolo, il Cricervo, il Ragno Tenore, i Ginnasti Uccellini, Monstero e Monstera, il Grande Naso Reciso e addirittura la stessa Santacroce, che si fa personaggio. Tutti insomma, meno che un insegnante di grammatica, perché Lulù, dalla prima pagina all’ultima, parla così: “Mi piaceresse vedere quello scricchiolo, ma forse volasse poco perché pesasse”. Quindi, da un lato: “Si piegavano le corolle dei fiori al cospetto di quel brillante chiarore, e le chiome degli alberi brillavano come mele ricoperte di zucchero, quasi il vento fermandosi ne avesse caramellato le foglie”, e dall’altro “Sì, sono quella bambina che sconfiggesse tutto perché fosse forte, e poi nei disegni quella bambina sorridesse molto perché avesse vinto”.
La storia è annacquatissima, la trama non avanza, è solo infarcita di esempi su come le sorelle (due gemelle che come da iconografia dicono la stessa cosa) siano cattive verso la povera Lulù, eppure l’autrice ha sentito il bisogno di suddividere il romanzo in quattro parti: la Commozione, lo Sbalordimento, le Tenebre, lo Smarrimento (cui andrebbe aggiunta una quinta: lo sfrantumamento).
L’intento pedagogico del romanzo è chiaro – “La gente preferisce guardare, non vedere” -, ma se questo è un libro che vorrebbe insegnare ad accettare la difformità, se integrare il diverso è cosa buona e giusta, allora Isabella, non potevi raccontarlo in 100 pagine?
per BookAvenue, Paola Manduca
Il libro
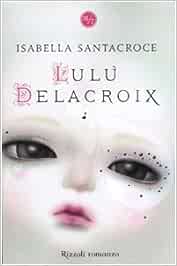
Isabella Santacroce,
Lulù Delacroix,
Rizzoli