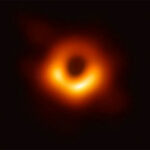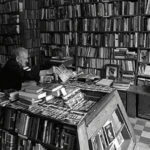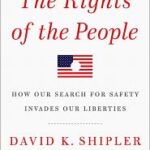.
Ci sarebbero alcune ragioni per confutare l’idea del tre numero perfetto, non fosse altro per una regola risalente a Euclide secondo cui la perfezione di un numero sta nella coincidenza della somma dei suoi divisori con il numero in questione. Se dovessimo dare retta alla regola, il numero perfetto più piccolo è, dunque, il ”6”, ma il nuovo libro di Marco Crestani, L’armonia del tre, appena pubblicato da Fallone, ambisce ad altro.
Il saggio raccoglie, a dirla con le prime righe, un caleidoscopio intellettuale apparentemente disordinato, che mette insieme solo in apparenza concetti ed elementi assai eterogenei tra loro e che trovano, invece, sostanza e filo logico che li accomuna: una eterna ghirlanda brillante per citare il famoso libro di Douglas Hofstadter, da cui prendo a prestito il titolo per queste righe.
Se qualcuno chiedesse “Cosa ha causato l’uragano Katrina?”, una risposta normale sarebbe l’evaporazione dell’acqua calda dell’oceano, o qualcosa del genere. Questa, è una spiegazione sbrigativa che chiarisce la causa di un uragano. Si potrebbe andare un po’ più a fondo e dire che gli uragani sono causati da un gruppo di molecole d’acqua che interagiscono tra loro. Anche questo è corretto, ma non è molto utile: ogni volta che accade qualcosa, è in definitiva dovuto all’interazione di atomi con altri atomi. Potrebbe aiutare sapere che al di sopra degli atomi (fisica) c’è il mondo delle molecole e delle reazioni chimiche (chimica), e al di sopra ancora c’è il mondo delle cellule (biologia). Tre elementi, dunque: il conto torna.
Un po’ più avanti, Marco Crestani espone la centralità del cuore, visto come centro pulsante e pulsionale, in relazione con gli animali e il buio. Ora, analizzare miliardi di singole cellule cardiache non ci aiuta a capire cosa fa un cuore. Dobbiamo, invece, trascendere la fisiologia e avventurarci nel regno della filosofia, dove cerchiamo di comprenderne lo scopo. Lo scopo di un cuore è pompare il sangue. Il concetto di “pompa” non è visibile a livello atomico, né a livello molecolare, nemmeno a livello biologico. Ma con una sola parola, “pompa”, si possono descrivere l’interazione di milioni di atomi e miliardi di cellule. Non solo questo è il modo migliore per spiegare un cuore, ma è anche l’unico modo. Tutta la nostra esistenza è costituita da processi fisici molecolari che astraiamo a livelli superiori per comprenderli. Inoltre, i processi fisici di livello più basso sono completamente irrilevanti per qualsiasi obiettivo che stiamo cercando di raggiungere.
L’astrazione è un processo mediante il quale la complessità viene resa comprensibile, dandoci la capacità di imparare. Così come non possiamo comprendere un uragano osservando le molecole d’acqua, cosi per il tramite di Marco Crestani, si capisce che non possiamo comprendere veramente la coscienza osservando i neuroni. Perché uomini e animali, a un certo punto, si comprendono reciprocamente. Quel momento di intesa, dice, “dove il confine tra la nostra comprensione e il loro silenzio si dissolve”.
Consideriamo un esempio di astrazione: la mente. Così come non possiamo comprendere un uragano osservando le molecole d’acqua, si diceva prima, non possiamo comprendere veramente la coscienza osservandone la sola fisiologia. Non è questione solo di come funzionano i neuroni, ci sono solleciti di altra natura come simboli, che rappresentano concetti autonomi.
A proposito di simboli. Quando vediamo un cane, un gruppo di neuroni si attiva insieme, rappresentando “cane”. Il simbolo di un cane è semplicemente questo gruppo di neuroni che si attiva quando ne vediamo uno. Gruppi di simboli formano pensieri. Infine, in alto, c’è “Io”, che è un insieme di pensieri che si combinano per formare un senso di sé – ne parleremo più avanti. La semiologia si occupa di questo.
Tuttavia, non tutti gli esseri viventi raggiungono il vertice di questa gerarchia. Più si sale, più si dice di essere “coscienti”. Sebbene tutto sia composto da atomi, meno hanno simboli e pensieri e ancora meno avranno un senso di sé. Questo si traduce in una “gerarchia della coscienza”.
Gli esseri umani mantengono un senso di sé pienamente sviluppato, che rappresenta il massimo grado di coscienza. Ma alcuni esseri umani ne hanno meno di altri: i neonati e gli anziani, sono due esempi. Chiedo: i cani hanno un senso di sé? Se un cane si guarda allo specchio, pensa: “sono io”? Forse, ciò che conta è la posizione rispetto agli altri. Non importa se un cane abbia un senso di sé, ma piuttosto che sia inferiore a un essere umano e superiore a un’ape. Nei “Sussurri dell’anima”, Crestani dice: “I simboli non si limitano a trasmettere informazioni, evocano emozioni, sensazioni esperienze”.
L’idea di relatività all’interno della gerarchia è importante perché funge da classifica di quanto ci preoccupiamo per qualcosa o qualcuno. Perché uccidiamo una zanzara che ronza ma non un cane che abbaia? Perché i vegetariani mangiano bene le piante ma non gli animali? I malati mentali dovrebbero essere costretti a entrare in istituto? Perché piangiamo quando muore il nostro cane ma non il pesce rosso nella vaschetta in cucina? Queste sono tutte domande che riguardano la gerarchia della coscienza. Facciamo cose agli esseri a un livello della gerarchia che sarebbero impensabili ad altri livelli.
L’intenzione di Marco Crestani, quando ci induce a questo concetto, è che la coscienza non sia binaria ma graduale. Proprio come il senso dell'”io” di un cane è meno sviluppato di quello di un essere umano, anche esseri umani diversi hanno diversi gradi di coscienza.
Il che ci porta a “Io”.
Cosa significa per l'”Io” essere al vertice della gerarchia della coscienza? Proprio come comprendere la funzione del cuore trascende l’analisi delle cellule, cogliere l’essenza dell'”Io” non può essere fatto attraverso un esame neurologico. Questo “Io” sintetizza le nostre azioni, i nostri desideri e le nostre convinzioni in una autoconsapevolezza unitaria, fornendo un fondamento filosofico per comprendere la nostra stessa esistenza. Ricorda che il livello filosofico ha a che fare con lo scopo: lo scopo di un cuore è pompare, mentre lo scopo dei nostri pensieri (ovvero desideri, convinzioni, ecc.) è il nostro senso di sé.
Tempus fugit
L’Autore riassume nei tre cardini filosofici del carpe diem di Orazio, il memento mori dei frati trappisti seicenteschi e l’utilitarismo di Pascal, la prospettiva di una vita in un perenne equilibrio instabile, per dirla con le sue parole, per poi essere consegnata all’incertezza del poi. Vale la pena, dice, vivere questa scommessa attraverso il mondo consapevole con cui abbracciamo il presente riflettendo su qualcosa che ci trascenda.
Questo punto di vista mi ha ricordato la lezione di Lutero. Max Weber si domanda come mai gli imprenditori del suo tempo, la maggior parte di essi in Germania, sia di religione protestante. Nello spirito dell’epoca, la comunione di idee e di valori sono il segno distintivo delle condizioni culturali che ne hanno favorito lo sviluppo identificandole nell’ottica religiosa nata con la riforma protestante diffusa nelle comunità ascetiche di matrice calvinista.
Se, come ricordato nel: “Ricordati che devi morire”, dei frati trappisti citati in precedenza, la massima di Benjamin Franklin a metà del settecento ricordata in una proverbiale frase l’essenza del suo tempo “Ricordati che il tempo e denaro”, riassume la vocazione dell’individuo cui aspirare. Weber scorge una serie di valori (che chiama spirito del capitalismo) destinati a orientare la vita pratica degli uomini. Il guadagno non è altro che un mezzo per raggiungere un altro fine: una ricchezza a beneficio di molti per compiacere Dio. Il Beruf: l’idea di vocazione al lavoro. L’obbligo morale come spinta che muove il singolo nella sua opera professionale, quale che sia, come indice di virtù da realizzare.
Finisco. L’armonia del tre è scritto bene e in maniera semplice, intendendo facile da leggere, ma non è un libro facile. Questo non vuol dire che non sia un libro molto, molto bello, ma non posso negare una certa –mia- difficoltà di lettura. E tuttavia, questa difficoltà è ciò che darà longevità al libro. Se volete intraprendere un viaggio che, attraverso i suoi vincoli intellettuali e concetti affascinanti metterà alla prova la vostra mente e altererà leggermente il vostro modo di vedere i vostri limiti, allora leggete questo saggio. Parte dell’esperienza sta nell’affrontare i suoi diversi media, dai dialoghi alle immagini, dagli enigmi alle pagine di simboli.
L’armonia del tre è ciò che si ottiene quando un giovane eclettico decide di mettersi alla prova. La maggior parte dei libri sono rilassanti da leggere: L’armonia del tre è la versione intellettuale di una maratona. In questo straordinario parnaso, è facile capirne il senso complessivo anche in un apparente caos di argomenti eterogenei in un equilibrio che tiene insieme tutte le cose. Dalla biologia alla musica, dalla filosofia alla storia, dalla letteratura alle scienze naturali, Marco Crestani offre modalità e silenziose riflessioni su come tenere assieme la nostra relazione con il creato e con il mondo. Una mappa dove trovare in quell’antropocentrismo, di cui il cenno a Meneghello, la giusta posizione di noi dentro l’equilibrio precario della geografia umana e naturale.
per BookAvenue, Michele Genchi
Il libro
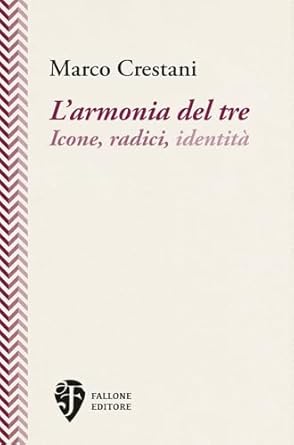
Marco Crestani,
L’armonia del Tre,
Icone, radici, identità,
Fallone editore
ed. 2025 pp. 228
.
ultimi articoli dell’autore