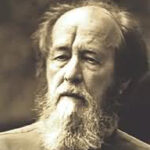.
Revolutionary Road, il celebre romanzo dell’americano Richard Yates (1926-1992) pubblicato nel 1961 e ambientato nel 1955, è una seminale, spietata biopsia dei maligni tessuti patologici che covavano dentro le ridenti casette suburbane celebrate dal cinema americano e invidiate dal resto del pianeta.
La storia si apre con un apparentemente insignificante fiasco teatrale della filodrammatica di Revolutionary Road (una delle tante bedroom communities, ovvero le comunità residenziali attornianti l’agglomerato di New York), la cui portata travalicherà viceversa i circoscritti limiti dell’insuccesso amatoriale per divenire l’inatteso segnale tellurico del fallimento della vita di Frank Wheeler, di sua moglie April (attrice principale della filodrammatica), dei loro due bambini Jennifer e Michael. Vale a dire di una famiglia tra le più apparentemente invidiabili di Revolutionary Road (il nome, che si riferisce alla rivoluzione americana, è usato chiaramente in chiave ironica, non essendoci nella maniera più assoluta all’interno del comprensorio residenziale nulla di rivoluzionario, e viceversa molto di mortalmente conformistico, noioso, normale).
Veramente, Frank Wheeler è solo esteriormente normale. Dentro di sé egli si sente infatti – e con molta velleitaria supponenza – uno spaesato «intellettuale all’europea», che è avvilito e al tempo stesso oppresso dai soffitti bassi e dall’aria ferma di Revolutionary Road, desideroso soltanto di poterne al più presto evadere come da un carcere. Sempre più spinto dal suo intellettualismo immaginario, e dalla presunzione di superiorità, egli vedrà a un certo punto la salvezza per sé e per la (in apparenza consenziente, ma in realtà piuttosto disorientata) consorte April in un radicale trasferimento dell’intera famiglia a Parigi: ovvero vivere nel cuore stesso di quel vagheggiato giardino europeo che si promette miticamente colmo di aria fresca e libertà intellettuale, e dove i Wheeler potranno finalmente sottrarsi al filisteismo di Revolutionary Road e dell’America.
L’infantile progetto di fuga però abortisce ancor prima della partenza per la Francia. E si lascia dietro, inevitabilmente, un abisso di frustrazione e malessere. Sarà questo il momento della verità. Alla quale Frank reagirà – come sempre – con l’arma dell’elusione e del suo invulnerabile narcisismo, passando tranquillamente al nuovo autoinganno che gli viene offerto da un’insperata prospettiva di carriera in quel lavoro che sempre aveva (a parole, sue ovviamente) disprezzato. Ma che, viceversa, non eluderà per niente e anzi sconterà fino in fondo sua moglie April: un personaggio sensibile e fragile che la sofferenza autentica e l’onestà di fondo porteranno alla disperazione e quindi alla catastrofe.
Oltre a offrirci una indimenticabile cronaca di «bovarismo americano», nonché un terribile ritratto dell’«intellettuale» (fasullo o autentico), questo importante romanzo ci parla del sempre più labile e ambiguo diaframma che nella nostra società distingue emozione autentica e «teatro dell’emozione». Allorché l’alter ego dell’autore, Shep Campbell, riuscirà finalmente ad abbandonarsi a un pianto liberatorio, sarà soltanto per scoprire che «i suoi singhiozzi erano un po’ forzati, che ne esagerava lo strazio facendo sobbalzare le spalle senza necessità». Non è un caso infatti che all’interno dell’intera storia, pur avvolta com’è attorno a un ossessivo rapporto a due, non fiorisca una sola parola o immagine di autentica passione.
E proprio l’appartenenza a una generazione in bilico tra due epoche, tra “new deal” e “nuova frontiera”, consentì a Yates di cogliere le avvisaglie del “vicolo cieco” che per molti anni a venire – anche dopo i vari Kennedy, i figli dei fiori e la guerra del Vietnam – avrebbe continuato a chiudere strade su strade ai cittadini degli Stati Uniti. Probabilmente, malgrado le ufficiali iniezioni di ottimismo, l’ansia del vicolo cieco era nello spirito dei tempi, visto che altri due romanzi fondamentali di quel periodo contengono la parola strada nel titolo: On the Road (pubblicato nel 1957) di Jack Kerouac e End of the Road (1958) di John Barth. In ogni caso, va riconosciuto a Yates di non essersi limitato ad anticipare certe evoluzioni dell’indivuduo postmoderno – adolescenzialismo cronico, instabilità emotiva quale stato permanente, esasperante difficoltà ad accettare realtà e responsabilità – ma di avere intuito che questi nuovi tratti si sarebbero affermati di pari passo al “concetto assolutamente rivoluzionario dell’elaborazione elettronica dei dati”.
Ma anche volendo togliere a Yates la patente, peraltro non essenziale, di veggente, non è possibile dimenticare l’importanza che il suo meraviglioso romanzo ha rappresentato per due intere generazioni di scrittori, un’importanza che si estende ben al di là dell’influenza che gli viene in genere accreditata – quella su Carver e dintorni. E anche dimenticando quanti rumori bianchi e correzioni sono passati, per un verso o per l’altro, dalle parti di Revolutionary Road, nessuno potrà comunque negare che la storia narrata da Yates quarant’anni fa è ancora la nostra storia e continuerà a esserlo per molto tempo.
per BookAvenue, Michele Genchi
il libro
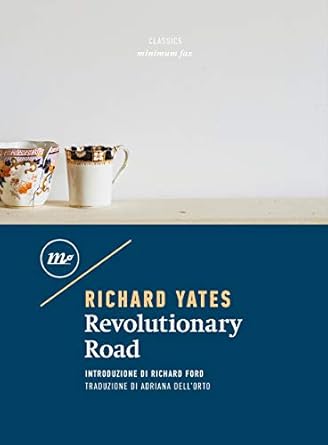
Richard Yates
Revolutionary road
Minimum Fax
ed. 2017 pp. 439
altri articoli dell’autore