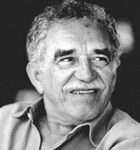.
Terza Puntata e ultima puntata. (seconda, prima)
Nella seconda puntata ho scritto di come la lettura di Dostoevskij aiuti il lettore a costruire un proprio metro di giudizio morale, di come spesso ci avvaliamo di scorciatoie etiche e dicome queste scorciatoie, oggi, consentono le aggressioni di uno stato verso l’altro in nome di un bene superiore, come il caso della guerra scatenata da Putin contro l’Ucraina.
Dostoevskij mostra molti dei suoi personaggi che parlano tra loro, usando il linguaggio per provocarsi o insultarsi a vicenda. Spesso questa violenza verbale funge da inevitabile preludio a reali e inquietanti atti di violenza nei suoi libri. E la violenza è onnipresente nei romanzi di Dostoevskij, caratterizzando praticamente tutte le storie che racconta. Forse per questo motivo, pochi autori sono così abili nel mostrare come siamo segnati dalla violenza. Dostoevskij ci mostra che tutto ciò che facciamo agli altri di immorale, lo portiamo anche dentro di noi: lo portiamo nella memoria di noi stessi, anche se ai margini della nostra memoria. Diventiamo le nostre azioni, che una volta realizzate possono significare qualcosa di molto diverso dalla fantasia che ne avevamo anticipato nella nostra mente. Storicamente, Delitto e castigo è stato il libro con cui i miei studenti si sono confrontati più da vicino e che hanno trovato il più accessibile. In Delitto e castigo , Dostoevskij ti cattura, si impegna in giochi etici con il lettore e gli studenti cavalcano, spesso con entusiasmo, queste montagne russe. Nel romanzo, un uomo sogna l’omicidio come potere, spinto da un illusorio movente altruistico, ma l’omicidio che compie non dimostra altro che forza bruta e disumanità: lo isola dalla famiglia umana. Senza cadere in inutili teorie di colpa collettiva, assistendo alla violenza russa in Ucraina, non posso fare a meno di pensare, avendo letto Dostoevskij, che la storia di questo Paese e di questa cultura sarà segnata da questa violenza perpetrata e apparentemente sanzionata in suo nome.
“Dostoevskij ci mette ripetutamente alla prova dal punto di vista etico, verificando se adottiamo scorciatoie etiche, se razionalizziamo mezzi orribili per giustificare un bene superiore immaginato.”
Per quanto rumorosi possano essere i romanzi di Dostoevskij, ciò che più mi ha attratta sono stati i momenti di quiete nelle sue opere: un inchino silenzioso, un bacio silenzioso e inspiegabile, o un tentativo di confortare qualcuno. Le strane premonizioni codificate nel silenzio dei gesti sono un linguaggio superiore in un mondo in cui il linguaggio non sempre funziona in modo comunicativo o confortante. La silenziosa sintassi dei gesti emerge nei momenti di massimo orrore, quando le leggi morali e umane sono state violate così gravemente, o stanno per esserlo, che la volatilità della parola non può fare nulla per fermare il danno. Tali momenti ci trascinano in uno stato esistenziale superiore. Descrivendo come si sente prima di un attacco epilettico, Myškin di Dostoevskij ne L’Idiota parla di come “tutta la sua agitazione, tutti i suoi dubbi, tutte le sue preoccupazioni fossero come placate all’improvviso, risolte in una sorta di sublime tranquillità, colma di gioia serena e armoniosa e di speranza, colma di ragione e causa ultima“. Poco dopo, osserva come “questi momenti, questi scorci fossero ancora solo un presentimento di quell’ultimo secondo (mai più di un secondo) da cui ebbe inizio l’attacco stesso. Quel secondo fu, ovviamente, insopportabile“. Leggo Dostoevskij per questa fragile calma, per momenti che erano più grandi della lingua, perché l’inglese non mi apparteneva ancora del tutto quando lo scoprii per la prima volta.
Questi momenti in Dostoevskij penetrano il linguaggio per me, alla ricerca di qualcosa di umano che sia più grande delle differenze culturali e del caos multilingue dell’immigrazione. In questi momenti Dostoevskij mi ha mostrato che la compassione può essere davvero potente, che può essere feroce e inflessibile nelle sue ricerche. Questo Dostoevskij, il mio Dostoevskij dei margini, vive dentro di me, lettrice, e non è cancellabile per me, nemmeno nella nostra epoca, con la sua propensione a cancellare libri e autori. Il mio Dostoevskij guarda Bucha e Mariupol e si contorce in un’ondata di repulsione morale: si ribella per chiedere conto, sebbene la sua fede nei sistemi sia così minima che non esiste una tabella di marcia per da dove tale conto possa provenire, ma io stesso posso facilmente indicare L’Aia.
Non mi interessa il culto di Dostoevskij, ma mi interessa uno scrittore che lascia che il lettore faccia propri i giudizi. Quel percorso personale di creazione di significato era l’essenza del mio percorso nelle arti liberali, un corso di studi che Putin detesta e che ha fatto tutto il possibile per sopprimere in Russia, inclusa la chiusura dello Smolny College of Liberal Arts di San Pietroburgo. Se dovessi azzardare un’ipotesi, odia le arti liberali perché insegnano a muoversi in qualsiasi panorama ideologico e a formarsi una propria opinione, e per gli autoritari non ha alcuna utilità il pensiero indipendente. Dostoevskij è stata la mia guida nelle arti liberali, perché ha formato la lettrice marginale in me, l’ha formata a leggere qualsiasi cosa in modo critico: dati, testi, tweet, comunicati stampa e falsità di Putin, e persino Dostoevskij stesso. Dostoevskij ha alimentato in me il desiderio e la libertà di pensare con la mia testa, e persino di denunciarlo quando ciò significa abbracciare l’indecenza.
Il mio Dostoevskij è avvincente nella sua capacità di compassione, e non da un’altezza canonica a spese e cancellazione di altri autori. Quel Dostoevskij mi ha dato il permesso di odiarlo se devo, di essere libera da ogni influenza ideologica, compresa la sua. Mi ha persino dato il permesso di denunciare il Dostoevskij di Putin. Ma Putin è un pessimo lettore, e Dostoevskij non gli appartiene. Io scelgo di aggrapparmi a Dostoevskij, di farlo appartenere a me e a tutti noi, soprattutto per questo.
Valeria Belledi
p.s. Grazie dell’attenzione.
ulimi articoli