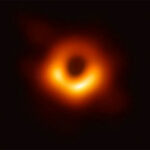.
Seconda puntata. (terza, prima)
Ho chiuso la prima puntata ricordando le idee nazionaliste di Dostoevskij attraverso gli studi che mi hanno formata di James Scanlan, un grande critico e filosofo, leggendario studioso della Ohio University. Scanlan, mancato nel 2016, documenta momenti negli scritti di Dostoevskij in cui il suo pensiero assume toni ancora più cupi, mostrando come l’autore sia giunto a considerare la Russia non solo superiore all’Occidente, ma anche un attore dominante tra gli altri popoli slavi. Per coloro che hanno assistito alla violenta aggressione russa contro l’Ucraina e alla negazione dell’identità ucraina da parte del presidente russo in favore dell’illusoria nozione di uno stato russo medievale originario, queste idee suonano inquietantemente familiari e pertinenti.
Ciò che è forse ancora più problematico, per quei lettori che, come me, potrebbero trovare avvincenti le idee di Dostoevskij su amore, accettazione e fratellanza, è che molte di queste idee positive non sono completamente separate dalle nozioni più cupe dell’autore.
Alla fine, l’autore arrivò a considerare la Russia come un luogo unico e privilegiato in cui accedere agli ideali cristiani da lui custoditi nella sua arte e, almeno in teoria, si sentì a suo agio con la possibilità che la Russia usasse la forza per raggiungere i suoi più ampi obiettivi messianici di estendere tali ideali ad altre nazionalità.
La monografia di Scanlan è uscita originariamente nel 2002, l’anno dopo del mio diploma statunitense e oltre vent’anni prima dell’aggressione russa in Ucraina. Da allora, la sua esplorazione accademica di Dostoevskij è diventata ancora più urgente e significativa. La lettura di Scanlan di Dostoevskij, suo lettore ai margini dell’autore, suona fin troppo positiva ai nostri giorni. “Il suo nazionalismo era innegabilmente imperfetto”, scrive Scanlan di Dostoevskij, “eppure, come cercherò di dimostrare, non era incoerente con la sua comprensione dell’ideale di amore e fratellanza cristiani”. Sebbene Scanlan smascheri molte delle idee problematiche di Dostoevskij, la sua intenzione originale non è quella di accusarlo. Scrive partendo da una prospettiva che vede l’evoluzione intellettuale dello scrittore e non sa quali orrori potessero essere possibili, quali orrori potessero essere giustificati attraverso le idee di Dostoevskij. Probabilmente anche Dostoevskij non lo sapeva, sebbene abbia approfondito la psicologia del male umano.
Una qualche versione del nazionalismo russo messianico di Dostoevskij permea pubblicamente i fondamenti ideologici e la giustificazione pubblica della violenta missione russa in Ucraina. Il governo russo non ha mostrato alcun riguardo per i confini territoriali dell’Ucraina e ha utilizzato il linguaggio della fratellanza slava ortodossa per giustificare l’attuale conquista territoriale neo-imperiale della Russia. A febbraio, durante la sua invettiva di due ore in un’intervista con Tucker Carlson, Vladimir Putin ha nuovamente negato l’esistenza storica dell’Ucraina, che falsamente annuncia come costruita da Lenin. Quando gli è stato chiesto di spiegare l’identità russa, Putin ha parlato della specificità della Russia rispetto all’Occidente e ha indicato Dostoevskij, uno scrittore popolare in Occidente, come colui che ha compreso più chiaramente l’anima russa. Anche il governo russo si posiziona quindi, con le sue opinioni, ai margini di Dostoevskij.
Non posso e non voglio rinunciare a Dostoevskij proprio perché Putin non può rivendicarlo come suo.
Dostoevskij, il pensatore nazionalista, è il Dostoevskij di Putin, e questo Dostoevskij risulta intollerabile al giorno d’oggi. Ma Dostoevskij stesso insiste nel non distogliere lo sguardo da verità scomode: quindi dobbiamo anche considerare tutti i suoi personaggi, se vogliamo avvicinarci alle sue idee nel nostro tempo. Il Cremlino sembra aggrapparsi a – e cercare di impossessarsi di – tutto ciò che è russo per poter portare avanti i suoi programmi perniciosi: colonizzare il passato, il presente e il futuro e attribuirgli determinati significati ideologici. Sono turbata da come il Cremlino abbia tentato di impossessarsi di Dostoevskij dai margini, e nella mia personale lotta con Dostoevskij, ci è voluto che Putin lo proclamasse alleato e portavoce per farmi capire che non posso e non voglio rinunciare a Dostoevskij proprio perché Putin non può rivendicarlo come suo. Il governo russo ha deciso di autoproclamarsi arbitro di ciò che è russo, di impossessarsi liberamente e di estirpare chiunque o qualsiasi idea che non sia in linea con le proprie. A volte si spingono fino a estremi limiti per liberarsi dalle contraddizioni. Proprio questo febbraio hanno assassinato il più acceso oppositore di Putin, il leader dell’opposizione russa Aleksej Navalnyj.
Tuttavia, presumere la fedeltà di Dostoevskij allo stato di polizia russo significa fraintenderlo, semplificare ciò che in lui è intenzionalmente complesso. Perché può esserci il Dostoevskij di Putin, ma c’è anche il Dostoevskij umanista, il mio Dostoevskij – perché i margini di Dostoevskij sono ampi. Ho davvero difficoltà con Dostoevskij solo perché, sapendo che nei suoi scritti ci sono idee profondamente problematiche e addirittura dannose, credo anche che le opere di Dostoevskij siano straordinariamente e miracolosamente perspicaci.
Ricordo di essere andata alla Columbia a New York da immigrata e ancora incerta su cosa significasse davvero fare un dottorato in una università negli Stati Uniti, e di essermi fatta strada tra scienze politiche, storia, archeologia classica (e pure recitazione), interrogandomi sulla filosofia e su Platone – per poi rendermi conto che potevo destreggiarmi in qualsiasi di queste discipline, ma la letteratura russa forniva lo spazio accademico in cui la mia passione poteva colmare le barriere linguistiche e l’alienazione culturale che dovevo superare per imparare. La prima tesi che ho scritto riguardava l’etica in Delitto e castigo di Dostoevskij e su come Dostoevskij ci induca a formulare giudizi morali sulla base di ragioni estetiche, su come ci metta ripetutamente alla prova dal punto di vista etico, verificando se ci avvaliamo di scorciatoie etiche, se razionalizziamo mezzi orribili per giustificare un immaginario bene superiore. Dostoevskij è il modo in cui ho iniziato a riflettere sul giudizio morale, su come trattiamo gli altri. Dostoevskij mi ha introdotta all’idea che a volte potremmo trattare gli altri meglio di quanto loro abbiano mai trattato noi per preservare la nostra integrità morale e dignità, per evitare danni morali a noi stessi.
Valeria Belledi
Fine seconda puntata>
La terza e ultima puntata, sarà pubblicata il 17 agosto
ultimi articoli