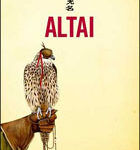I romanzi dedicati ai propri cari lasciano sempre uno strascico di sofferenza, probabilmente per quel grado di immedesimazione possibile da cui difficilmente si sfugge. Gli autori, oppure i narratori (a seconda dei casi), tentano forse di offrire in memoria una parte di sé inconfessabile o semplicemente desiderano liberarsi da qualcosa o qualcuno troppo vicino, carne della propria carne. Si tratta di una riabilitazione postuma del proprio stato di genitore o di figlio, oppure di una rivendicazione, come nel caso di Kafka che scrisse nel 1919 una lunga lettera al padre, pubblicata senza cercare una comunicazione diretta, e quindi una risoluzione rassicurante. Si rivolge al genitore di cui ha sempre avuto terrore, che teme e adora come si fa per i carnefici talvolta, quando non si hanno altre vie di fuga.
I romanzi dedicati ai propri cari lasciano sempre uno strascico di sofferenza, probabilmente per quel grado di immedesimazione possibile da cui difficilmente si sfugge. Gli autori, oppure i narratori (a seconda dei casi), tentano forse di offrire in memoria una parte di sé inconfessabile o semplicemente desiderano liberarsi da qualcosa o qualcuno troppo vicino, carne della propria carne. Si tratta di una riabilitazione postuma del proprio stato di genitore o di figlio, oppure di una rivendicazione, come nel caso di Kafka che scrisse nel 1919 una lunga lettera al padre, pubblicata senza cercare una comunicazione diretta, e quindi una risoluzione rassicurante. Si rivolge al genitore di cui ha sempre avuto terrore, che teme e adora come si fa per i carnefici talvolta, quando non si hanno altre vie di fuga.
Oriana Fallaci ha consegnato alla storia della letteratura un libro commovente e tormentato con “Lettera a un bambino mai nato” (1975), rivolgendosi di fatto a se stessa in quanto donna e a tutti i lettori che con lei avrebbero condiviso l’enigma della vita e la scelta di generare.
Di recente una straziante lettera è stata scritta dallo scrittore e pacifista israeliano David Grossman, al figlio Uri, caduto giovanissimo nella guerra israelo-libanese del 2006. E questa purtroppo non è letteratura, solo il risvolto improvviso e tragico della storia quotidiana. Pochi esempi che sottolineano comunque l’empatia che certi racconti possono suscitare nei confronti di chi legge, poiché siamo tutti o figli o padre o madre.
Nel libro di Claudio Volpe, Achille scrive ad Ettore, il figlio affetto da una sindrome che lo limita fortemente nella capacità di comprendere. Eppure il padre gli parla, rendendolo partecipe di ogni dettaglio della propria vita, gli confessa ogni cosa. Non crea un altare alla bellezza del suo pargolo, tuttavia lo rende perfetto vestendolo d’amore. Parla invece di sé, della sua imperfezione di uomo, dei suoi cedimenti, del suo baratro e della risalita. Perché di fronte alla propria creatura, ecco l’atto più coraggioso, non esiste un padre onnipotente creatore della perfezione; di fronte a un figlio l’amore più grande si manifesta lacerandosi l’anima e svelandola senza segreti, parlando senza pudore di quel vuoto intorno che si è cercato invano di esorcizzare, riempendolo anche con la più scellerata delle azioni nei confronti di se stessi.
Il vuoto intorno esiste e va guardato negli occhi. Altro che visione aristotelica del riempimento totale di ogni spazio; la scoperta di Otto von Guericke (1650) lo aveva smentito alla grande e da allora, filosofi, scienziati, uomini comuni hanno dovuto fare i conti con l’horror vacui dell’esistenza. Solo l’arte ha offerto sollievo. Lo diceva Mario Praz, pensando alle case vittoriane stipate di oggetti; ce ne hanno dato un esempio i più antichi manoscritti miniati e il fitto gioco di figure nei quadri del Medioriente e d’Oriente. E così anche il pop surrealism degli anni ’70 e l’Art Brut, o arte non convenzionale, in voga negli stessi anni negli ospedali psichiatrici. Riempire, riempire, altrimenti è troppo doloroso stare nel vuoto e averlo tutto intorno.
“Il vuoto è sempre stato il mio problema, il mio fardello inabilitante. Noi viviamo con la paura del vuoto, lavoriamo, amiamo, creiamo, facciamo arte, facciamo guerre, ci uccidiamo, per paura di venire divorati da quel maledetto vuoto affamato. La nostra storia è scandita dal vuoto. Per sconfiggere il vuoto della comunicazione abbiamo imparato a parlare, per combattere il vuoto del buio abbiamo imparato ad accendere il fuoco, per paura del vuoto della solitudine abbiamo imparato ad amar. Ma per quanto possiamo lottare, per quanto possiamo buttare il nostro sangue per azzerare quel vuoto, lui è sempre al suo posto accanto a noi.” E solo dopo aver tentato invano di colmarlo ammette: “Ho capito che l’unica via di salvezza, l’unica possibilità di redenzione, sarebbe stata farlo oscillare. Il vuoto che oscilla e che trema: questa è la strada.”
Un’oscillazione quindi, una vibrazione lunga che intercorre tra più esseri e fonda la solidarietà, questa la via d’uscita. Accettare che il vuoto ci sia e affrontarlo insieme col sorriso, come avviene nella fiaba cinese riportata nel testo, non a caso raccontata da uno scultore ad un Achille ancora ragazzino. L’artista maturo per eccellenza che ha imparato a dare una forma alla materia plasmandola secondo la visione di felicità che lo alberga dentro, non importa se fuori non c’è gioia. Lo scultore che fa nascere lentamente dall’argilla la vita e non “vomita” di getto la sua rabbia come farebbe uno scrittore, sembra suggerire l’autore.
Nella fiaba si racconta che un sant’uomo abbia chiesto a Dio di mostrargli il paradiso e l’inferno; lo scenario che si presenta pare identico: gli uomini seduti intorno ad un tavolo hanno dei cucchiai lunghissimi collegati alle braccia, in modo tale che non possono nutrirsi da soli. Quindi nell’inferno gli uomini sono emaciati e affranti; nel paradiso felici e in carne. Come è possibile? Con la solidarietà è possibile tutto, da soli non ci si può nutrire, tuttavia si può nutrire il vicino e questi farà lo stesso con chi gli è prossimo. “Inferno e paradiso sono uguali nella struttura. La differenza la portiamo dentro di noi!”
I temi affrontati dal romanzo dello scrittore esordiente, e già maturo nello stile, Claudio Volpe, sono talvolta duri da digerire: la violenza sui bambini, l’handicap, il sesso prostituito, l’accettazione dell’altro (in particolare degli zingari), l’eutanasia.
Le pagine scorrono emozionando e facendo riflettere sull’ipocrisia della cosiddetta normalità, sui sistemi falsi fondati sulle gerarchie genetiche (i figli non si dice forse che sono di chi li cresce e non di chi li fa?), sulla spiritualità come bisogno universale. E infine rimane la confessione fiume di un padre che ama il figlio, la storia misteriosa di come dal dolore possa generarsi vita e di come questa vita possa addirittura farsi felicità autentica.
Il libro di Claudio Volpe è edito da Edizioni Il Foglio di Piombino ed è attualmente in tour per l’Italia.