 L’ultima parte del romanzo ti cattura, acceleri nella lettura; vuoi capire come Elwood sia riuscito ad andarsene e, pur non trattandosi di un giallo, la curiosità cresce.
L’ultima parte del romanzo ti cattura, acceleri nella lettura; vuoi capire come Elwood sia riuscito ad andarsene e, pur non trattandosi di un giallo, la curiosità cresce.
Poi leggi quel paragrafo e ti fermi, sei sicuro di aver letto male -è già capitato- torni indietro e rileggi; ti rendi conto di aver letto bene, per sicurezza leggi per la terza volta le righe chiave. Non ti sei sbagliato, allora ti fermi e ti chiedi come sia possibile; ma basta continuare la lettura perché l’arcano sia svelato. Tutto torna a posto, ma il racconto prende un’altra piega, in parte cambia prospettiva. Ma ormai sei alla fine del romanzo, un racconto con il finale aperto: spetta a te, lettore, dopo che avrai chiuso il libro, scrivere la conclusione nella tua immaginazione tra le due ipotizzate dall’autore.
E adesso che hai chiuso il libro osserverai la copertina e vedrai quello che prima non avevi visto, perché è una splendida sintesi iconografica della narrazione.
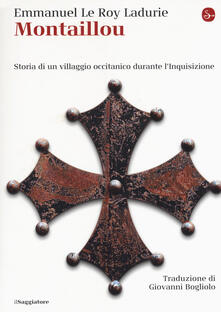 Ricordate la quarta di copertina scritta da Baricco per Prateria di Least Heat-Moon?
Ricordate la quarta di copertina scritta da Baricco per Prateria di Least Heat-Moon?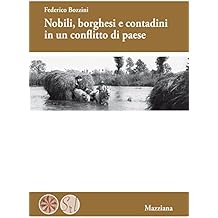 “Il Giovin Signore si trova ad agire in un contesto e in un tempo nei quali qualcuno si permette di mettere in discussione i privilegi del suo stato e i diritti del suo casato. Educato nella ferma certezza del suo rango, affronta le contestazioni e i nemici con l’assoluta sicurezza del suo buon diritto. Nel nuovo mondo in cui si trova a vivere e ad agire, la sua fermezza inconcussa appare come boria violenta e alterigia irresponsabile. Con l’educazione tardofeudale finisce per essere sfasato rispetto al suo tempo. Ogni questione finisce per sembrargli una questione d’onore. Sembra non aver capito che nell’Ottocento per tutelare efficacemente i propri interessi deve servirsi freddamente di avvocati e tribunali, e non usare in modo sanguigno di bravi e randelli.”
“Il Giovin Signore si trova ad agire in un contesto e in un tempo nei quali qualcuno si permette di mettere in discussione i privilegi del suo stato e i diritti del suo casato. Educato nella ferma certezza del suo rango, affronta le contestazioni e i nemici con l’assoluta sicurezza del suo buon diritto. Nel nuovo mondo in cui si trova a vivere e ad agire, la sua fermezza inconcussa appare come boria violenta e alterigia irresponsabile. Con l’educazione tardofeudale finisce per essere sfasato rispetto al suo tempo. Ogni questione finisce per sembrargli una questione d’onore. Sembra non aver capito che nell’Ottocento per tutelare efficacemente i propri interessi deve servirsi freddamente di avvocati e tribunali, e non usare in modo sanguigno di bravi e randelli.”
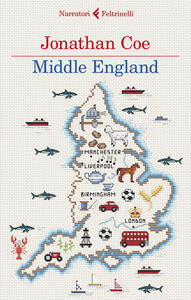 Per quanto mi sia fatto tre risate (di cui una grassa), cosa per me rara, non me la sento certo di dire che il libro si possa definire allegro. Non lo è, anzi molte pagine sono impregnate di amarezza, l’amarezza della sconfitta. Non solo l’insuccesso al referendum, ma la sconfitta di un modo di pensare e di un’idea di società. Ma nonostante questo Middle England di Jonathan Coe è decisamente di gradevole lettura e merita di essere letto.
Per quanto mi sia fatto tre risate (di cui una grassa), cosa per me rara, non me la sento certo di dire che il libro si possa definire allegro. Non lo è, anzi molte pagine sono impregnate di amarezza, l’amarezza della sconfitta. Non solo l’insuccesso al referendum, ma la sconfitta di un modo di pensare e di un’idea di società. Ma nonostante questo Middle England di Jonathan Coe è decisamente di gradevole lettura e merita di essere letto.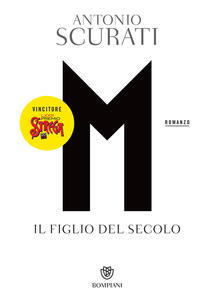 Innanzitutto tanto di cappello per la scrittura. Le oltre ottocento pagine non stancano il lettore, nonostante l’assenza di dialoghi. Una scrittura asciutta, a tratti essenziale, quella di Scurati; e laddove c’è un’abbondanza lessicale, questa non è mai fine a se stessa.
Innanzitutto tanto di cappello per la scrittura. Le oltre ottocento pagine non stancano il lettore, nonostante l’assenza di dialoghi. Una scrittura asciutta, a tratti essenziale, quella di Scurati; e laddove c’è un’abbondanza lessicale, questa non è mai fine a se stessa. Di Simon Winchester avevo già letto altro. Per cui quando ho preso in mano Il professore e il pazzo< mi è venuto spontaneo dargli un’occhiata. Anche perché la copertina fa simpatia, è buffa. L’abstract del testo mi inspirava, ma è quando ho letto le poche righe espunte dal testo in cui Winchester racconta l’incontro tra il Murray e Minor che ho capito che non potevo non leggerlo.
Di Simon Winchester avevo già letto altro. Per cui quando ho preso in mano Il professore e il pazzo< mi è venuto spontaneo dargli un’occhiata. Anche perché la copertina fa simpatia, è buffa. L’abstract del testo mi inspirava, ma è quando ho letto le poche righe espunte dal testo in cui Winchester racconta l’incontro tra il Murray e Minor che ho capito che non potevo non leggerlo. Ho terminato da poche ore il saggio in forma narrativa 1947 e non riesco a digerirlo, continuo a rimuginarci. È palese che il libro non mi ha lasciato indifferente. Se dovessi usare un aggettivo per definirlo direi: interessante. Ma sarebbe nascondere l’inquietudine che ha mi ha trasmesso. Ecco, la biografia di quell’anno del dopoguerra ti tramette le macerie nell’animo. Non perché descrive le macerie lasciate dalla seconda guerra mondiale, ma perché inocula l’assenza di speranza di quel libro. Non c’è speranza, né spazio per un mondo migliore. Sarò un pessimista, ma questo è ciò che ho ricavato dal libro. Continuo a rimuginare su quello che ho letto e vedo nella cronaca attuale quello che succedeva allora protrarsi senza sosta e senza speranza di soluzione. Ecco un altro aggettivo per quel libro: amaro.
Ho terminato da poche ore il saggio in forma narrativa 1947 e non riesco a digerirlo, continuo a rimuginarci. È palese che il libro non mi ha lasciato indifferente. Se dovessi usare un aggettivo per definirlo direi: interessante. Ma sarebbe nascondere l’inquietudine che ha mi ha trasmesso. Ecco, la biografia di quell’anno del dopoguerra ti tramette le macerie nell’animo. Non perché descrive le macerie lasciate dalla seconda guerra mondiale, ma perché inocula l’assenza di speranza di quel libro. Non c’è speranza, né spazio per un mondo migliore. Sarò un pessimista, ma questo è ciò che ho ricavato dal libro. Continuo a rimuginare su quello che ho letto e vedo nella cronaca attuale quello che succedeva allora protrarsi senza sosta e senza speranza di soluzione. Ecco un altro aggettivo per quel libro: amaro.