 I conflitti armati che hanno funestato il secolo scorso, e non sembrano destinati a cessare, sono la prova di quanto sia illusoria l’idea del “pacifismo lacrimoso” di cui parla Aldous Huxley: l’idea cioè che basti mostrare agli uomini le crudeltà della guerra perchè essi finalmente vi rinuncino. E’ urgente invece, secondo Eibl-Eibesfeldt , elaborare una nuova cultura della pace che, spazzando via ogni pregiudizo antropocentrico, riconosca la realtà istintuale che condiziona i nostri comportamenti.
I conflitti armati che hanno funestato il secolo scorso, e non sembrano destinati a cessare, sono la prova di quanto sia illusoria l’idea del “pacifismo lacrimoso” di cui parla Aldous Huxley: l’idea cioè che basti mostrare agli uomini le crudeltà della guerra perchè essi finalmente vi rinuncino. E’ urgente invece, secondo Eibl-Eibesfeldt , elaborare una nuova cultura della pace che, spazzando via ogni pregiudizo antropocentrico, riconosca la realtà istintuale che condiziona i nostri comportamenti.
Le ricerche condotte per anni dall’autore hanno contribuito a demistificare i luoghi comuni del buon selvaggio e di società animali idilliache: l’aggressività è diffusa ovunque, ma è sciocco colpevolizzare una funzione naturale per il semplice fatto che l’abbiamo in comune con la bestia. Proprio dal regno animale viene invece la prova che la natura ha imboccato la strada della risoluzione non violenta dei conflitti.
Fra i vertebrati le lotte per il rango e per il territorio raramente portano all’uccisione di un individuo della stessa specie perchè il coflitto assume forme ritualizzate, dove rimane solo una traccia della originaria distruttività. La via alla pacificazione resta aperta, perchè segnali di acquietamento bloccano la spirale pericolosa della violenza.
Così nell’animale e così anche nell’uomo; non però nel conflitto fra gruppi, dove per una sorta di malaugurata mutazione culturale (la speciazione”) i freni inibitori perdono ogni efficacia.
Eibl-Eibesfeldt distingue innanzitutto fra l’aggressività in generale -che è un fenomeno biologico, individuale e interno al gruppo e la guerra, la quale rappresenta invece un prodotto dell’evoluzione culturale. Il paradosso, rispetto a tante semplificazioni e pregiudizi antietologici, è che “al filtro di norme biologiche, che anche nell’uomo costituisce un freno alla distruttività, viene sovrapposto un filtro di norme culturali, che impone di uccidere” (Etologia della guerra, pag. 129). In quanto fenomeno storico, la guerra è quindi superabile e la pace mondiale non è soltanto una bella utopia, a patto che della guerra si comprendano funzione e struttura.
L’universalità dei conflitti fra gli esseri umani è data soprattutto da tre fattori: il mantenimento delle distanze tra gruppi culturali, il reperimento delle risorse necessarie alla sopravvivenza, il rafforzamento dell’identità tribale. Territorialismi, tecnologie belliche, diplomazie sono delle strutture funzionali a questi scopi.
Partendo da questa intenzione, diventa possibile cogliere l’effettiva struttura di molti fenomeni. Contrariamente alla guerra, l’aggressività è innata ma lo è perché indispensabile alla sopravvivenza (aggressività difensiva), all’evoluzione (aggressività adattativa), alla maturazione del singolo (aggressività esplorativa). Quest’ultima consiste nella necessità, da parte del bambino, di saggiare l’ambiente e valutare se stesso, scoprendo in tal modo i limiti fino ai quali gli è concesso spingersi.
“Non è l’aggressività che si è sviluppata allo scopo di costituire una gerarchia di rango, bensì è quest’ultima che si è sviluppata come un meccanismo per venire a capo dell’aggressività interna al gruppo, aggressività che da altri punti di vista è vantaggiosa” dice l’autore.
E’ utile a questo proposito leggersi pure qualche libro di Konrad Lorenz. Sottolineando la cultura della guerra e l’istintività della pace, Eibl-Eibesfeldt sfata questo pregiudizio e mostra l’aggressività per quello che è: un impulso innato ma funzionale e orientabile verso l’evoluzione come verso l’autodistruttività. La scelta dipende da noi, dal coraggio della cultura. “…c’è del marcio nella specie Homo Sapiens” (Otto peccati capitali…, 127). Questa è la semplice, financo banale, ma importantissima constatazione da cui parte Konrad Lorenz per descrivere i rischi e le storture di cui è vittima l’umanità contemporanea. I più importanti fra essi sono: la sovrappopolazione che scatena aggressività , la devastazione dello spazio vitale, la competizione esasperata fra gli uomini, il venir meno dei sentimenti, il deterioramento dello stesso patrimonio genetico, il rifiuto violento della tradizione, l’indottrinamento esasperato, le armi (comprese quelle nucleari).
Con aggressività si intende il conflitto specifico, diretto contro membri della stessa specie e non quello delle varie specie fra di loro. La lotta per la sopravvivenza, di cui parla Darwin, è appunto questa ed è la sola che faccia progredire l’evoluzione. Senonché tale lotta è diventata “nell’attuale situazione storico-culturale e tecnologica dell’umanità il più grave di tutti i pericoli” (sempre Lorenz, Aggressività, p.66). La concorrenza sfrenata fra gli uomini per l’utilizzo delle risorse rischia, infatti, di cacciare l’evoluzione in un vicolo cieco non funzionale e dunque potenzialmente autodistruttivo.
Eibensfeldt cerca prima di tutto di spiegare i nessi causali che hanno condotto a un simile risultato. Tutti i grandi predatori hanno dovuto sviluppare, nel corso della filogenesi, una radicale inibizione a usare le loro potenti armi naturali contro membri della stessa specie, pena l’inevitabile estinzione. Un lupo, ad esempio, non ucciderà mai un altro lupo che gli offre la gola in segno di sottomissione, e basterebbe un semplice morso. Qui l’inibizione è fortissima e agisce sistematicamente. Nell’uomo invece essa è assente in quanto egli è privo di armi naturali con le quali possa, in un sol colpo, uccidere una grossa preda: “nessuna pressione selettiva si formò nella preistoria dell’umanità per generare meccanismi inibitori che evitassero l’uccisione di conspecifici finché, tutto d’un tratto, l’invenzione di armi artificiali portò lo squilibrio fra la capacità omicida e le inibizioni sociali.
Da qui il proliferare patologico di una violenza senza freni, esercitata mediante armi che colpiscono da lontano e in modo anonimo, rafforzata dall’evidente contrasto fra la nobiltà dei valori etici come la tolleranza e il cosmopolitismo e il permanere di istinti (fondamentali) atavici come la difesa del proprio gruppo e del proprio territorio contro qualunque invasore ed ogni possibile minaccia.
per BookAvenue, Michele Genchi
Irenaus Eibl Eibesfeldt, Etologia della guerra, Boringhieri


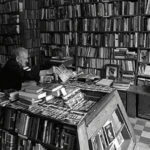
Avevo letto solo la prima parte 🙂 oggi pomeriggio, effettivamente troppo breve per i tuoi standard 😉
comunque mi piace, bello.
Aveva ragione a proposito della Libia. Bello l’articolo.