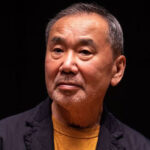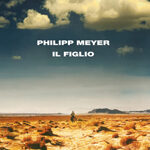.
Respiro profondamente e sento che la vacanza si dispiega davanti a me come un territorio inesplorato dell’anima. Non è semplicemente una pausa: è l’occasione preziosa per riscoprire quella dimensione interiore che la velocità quotidiana tende a soffocare.
Mi ascolto con un’attenzione nuova e nel silenzio fertile di questi giorni sospesi, emergono parole che credevo perdute, suoni dell’anima che riconoscono la loro antica melodia.
La vacanza non è fuga dal mondo, ma immersione profonda nella vita; non è vuoto da riempire, ma pienezza da assaporare.
La vacanza non è fuga dal mondo, ma immersione profonda nella vita
Cammino con Paola sotto un sole che definire “generoso” sarebbe un eufemismo. La Val Tiberina si stende davanti a noi come un palcoscenico arroventato, dove ogni passo diventa una piccola negoziazione con la canicola. Cerchiamo l’acqua che sembra evaporare prima ancora di raggiungerci, mentre i chilometri si accumulano sotto le suole come debiti da saldare.
Il Monte Fungaia rimane lì, immobile nella sua promessa sempre rimandata – una meta che si comporta come un miraggio educato, presente, ma mai raggiungibile.
La salita procede con quella lentezza inesorabile che trasforma i polpacci in protagonisti involontari di questa storia. Ogni metro conquistato verso l’alto costa il suo tributo muscolare, ma avanziamo con la determinazione di chi sa che fermarsi significherebbe arrendersi al paesaggio.
Raggiungiamo Rocca Cignata e scorgiamo da lontano ciò che il tempo ha lasciato in eredità. I resti giacciono su proprietà privata – una cortesia che impedisce l’accesso pubblico a questi frammenti di storia. Osserviamo da distanza rispettosa quello che un tempo dominava il territorio circostante.
Il nome stesso racconta la sua origine: Rocca Cignata, il castello che sorgeva sul massiccio roccioso del versante occidentale del Monte Fungaia. Questo rilievo funge da spartiacque naturale tra il Tevere e il Singerna, prima che i due corsi d’acqua si concedano il lusso di confluire nell’invaso di Montedoglio. Ci troviamo in una posizione privilegiata, da cui l’intera valle del Singerna si dispiega ancora oggi come un libro aperto sulla geografia del territorio.
La conformazione circolare del poggio roccioso, unita alla possibilità di controllare ampie porzioni di territorio, deve aver suggerito ai conti di Galbino, Montauto e Montedoglio, intorno al 900 d.C., di fondare qui questa fortificazione. Il toponimo “Cignata” – o “Cingiata” – deriva probabilmente dal participio passato del verbo “cingere”, termine che descriveva le strutture difensive circondate da mura. Dal basso, questi bastioni dovevano presentarsi con un’imponenza che il dislivello amplificava notevolmente.
Con la fine del medioevo, la fortificazione cede importanza agli edifici che si distribuiscono nella campagna sottostante, degradando dolcemente verso il Singerna. Osservata con attenzione appropriata, Rocca Cignata e il suo poggio offrono l’opportunità di decifrare l’essenza storica di un paesaggio che, scendendo dall’Alpe di Catenaia verso la piana del Tevere, era punteggiato dai castelli di Caprese, Cignata, Montedoglio, Montauto, Galbino, Pianettole, Sorci e dalle altre fortificazioni dell’attuale versante umbro.
Riprendiamo il cammino, dimenticando convenientemente che camminare nelle ore centrali di agosto, a cavallo del mezzogiorno sotto il solleone, rientra nella categoria delle decisioni discutibili. Ma procediamo comunque, perché fermarsi richiederebbe una saggezza che al momento nessuno di noi due possiede.
Per limitare i rischi di insolazione – termine che suona più drammatico della realtà – ci dotiamo di cappellino e bandana. Precauzioni che si rivelano insufficienti contro un caldo che definire “vivace” sarebbe un understatement. Ci perdiamo tra i sentieri, camminiamo in uno stato che oscilla tra l’ebbrezza e la leggera alterazione termica. Una sensazione di euforia ci pervade e iniziamo a cantare, come se la temperatura avesse liberato qualche meccanismo primitivo di sopravvivenza basato sul buonumore.
Improvvisamente appare un sentiero CAI che riconosco – o credo di riconoscere. Attraverso il lago su un ponte modernissimo che sembra materializzato lì appositamente per il nostro passaggio. Superiamo “seccatoi” di castagne e borghi che hanno scelto l’abbandono come forma di esistenza, seguendo la strada asfaltata che, con questo caldo, si trasforma in una versione domestica del deserto del Sahara.
Cominciano le visioni – o quello che generosamente potrei chiamare “fenomeni ottici dovuti al calore”. Dopo alcuni chilometri percorsi in questo stato di alterazione da temperatura, entriamo in un gruppo di case dove un furgone della “Bofrost” compie quello che definirei senza esagerazione un salvataggio. Ci vende una scatola di sei ghiaccioli che rappresentano la soluzione ideale ai nostri problemi termici.
Ghiaccioli che non assaporiamo dai tempi dell’adolescenza, ma che ora ci appaiono come il pasto più straordinario e raffinato che la civiltà umana abbia mai concepito. Li consumiamo con la devozione di chi ha riscoperto il significato profondo del refrigerio, trasformando un semplice gelato industriale nella conclusione perfetta di una strana piccola odissea termica.
Marco Crestani
altri articoli dell’autore