
Nei giorni scorsi si è molto parlato della fusione Mondadori-Rcs. Questo è il commento di Bookavenue.
Gli ultimi dati forniti dall’Istat sulla lettura nel nostro Paese nel 2014 (e da noi prontamente forniti ai lettori del sito) sono assai severi. Parlano di circa ottocentomila lettori in meno rispetto l’anno precedente. Meno della metà delle persone campionate (il 41% circa) dai sei anni (!) in poi, ha letto almeno – un solo – libro non scolastico o per le professioni. Si capisce che, su una popolazione di cinquantasette milioni, ben trentaquattro di questi non leggono; quel 41% citato prima, a guardar bene, si compone da: dieci milioni circa che leggono da uno a tre libri, sei milioni da quattro a sei, tre e mezzo tra i sette e undici e, per finire, tre milioni e mezzo leggono più di dodici libri l’anno: i cosiddetti lettori forti. Quelli in mezzo (da quattro a 11) sono i medi, il resto sono i lettori deboli.
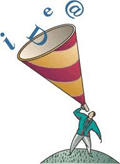
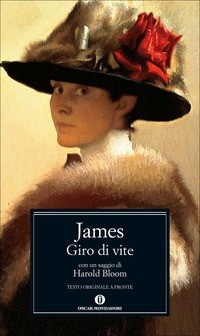
 E’ inizio estate e i quotidiani mi consegnano immagini scioccanti. Da un lato vedo l’orrore iracheno e l’avanzata di un’ideologia politica e religiosa estrema, dall’altro la cronaca nostrana di un irreprensibile marito-figlio modello che stermina moglie e bambini per recuperare una fantomatica libertà. Mister Hyde è tra noi e fortunatamente è in questi giorni che sto rileggendo Giro di vite di Henry James.
E’ inizio estate e i quotidiani mi consegnano immagini scioccanti. Da un lato vedo l’orrore iracheno e l’avanzata di un’ideologia politica e religiosa estrema, dall’altro la cronaca nostrana di un irreprensibile marito-figlio modello che stermina moglie e bambini per recuperare una fantomatica libertà. Mister Hyde è tra noi e fortunatamente è in questi giorni che sto rileggendo Giro di vite di Henry James.
 Garcia Màrquez si è spento a casa sua con la moglie e i suoi due figli accanto. Lo aveva chiesto ai medici quasi presagendo l’imminente fine; voleva tornare a casa dopo essere stato colpito dalla polmonite e nonostante il rischio di complicazioni dato il suo cagionevole stato di salute. Questo grande scrittore del mondo intero ci ha lasciati, ieri, a 87 anni.
Garcia Màrquez si è spento a casa sua con la moglie e i suoi due figli accanto. Lo aveva chiesto ai medici quasi presagendo l’imminente fine; voleva tornare a casa dopo essere stato colpito dalla polmonite e nonostante il rischio di complicazioni dato il suo cagionevole stato di salute. Questo grande scrittore del mondo intero ci ha lasciati, ieri, a 87 anni.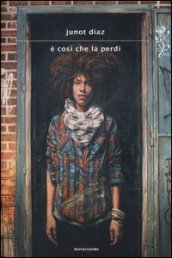 Come molti grandi libri, “E’ cosi che la perdi” ti mette voglia di fare pulizia. Vuoi andare davanti agli scaffali di casa e tirare giù tutti i romanzi che hai comprato per sbaglio. La raccolta di racconti di Junot Diaz, quello per capirci di “La breve favolosa vita di Oscar Wao” (
Come molti grandi libri, “E’ cosi che la perdi” ti mette voglia di fare pulizia. Vuoi andare davanti agli scaffali di casa e tirare giù tutti i romanzi che hai comprato per sbaglio. La raccolta di racconti di Junot Diaz, quello per capirci di “La breve favolosa vita di Oscar Wao” (
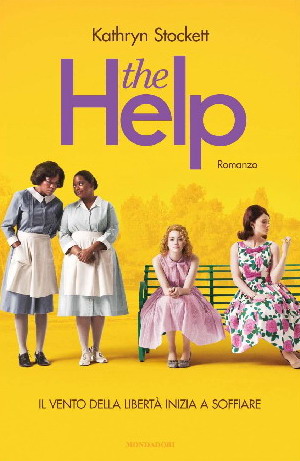
 Il 1 dicembre 1991 il New York Times pubblicò un articolo che a suo modo avrebbe cambiato la storia. Si trattava di un racconto in prima persona intitolato Grady’s Gift (Il dono di Grady) e l’autore era Howell Raines, un editorialista che sarebbe stato tra i più feroci critici di J.W. Bush. L’anno successivo l’articolo ottenne il Pulitzer Prize for Feature Writing, il massimo riconoscimento del giornalismo mondiale. Dieci anni dopo invece, Raines sarebbe diventato direttore del giornale e il Corriere della Sera avrebbe titolato: “Il New York Times svolta a sinistra”.
Il 1 dicembre 1991 il New York Times pubblicò un articolo che a suo modo avrebbe cambiato la storia. Si trattava di un racconto in prima persona intitolato Grady’s Gift (Il dono di Grady) e l’autore era Howell Raines, un editorialista che sarebbe stato tra i più feroci critici di J.W. Bush. L’anno successivo l’articolo ottenne il Pulitzer Prize for Feature Writing, il massimo riconoscimento del giornalismo mondiale. Dieci anni dopo invece, Raines sarebbe diventato direttore del giornale e il Corriere della Sera avrebbe titolato: “Il New York Times svolta a sinistra”.
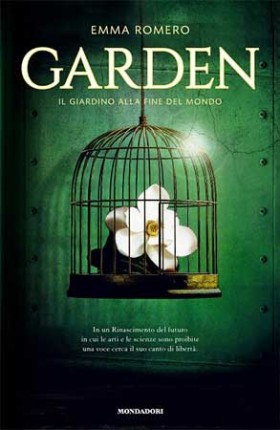

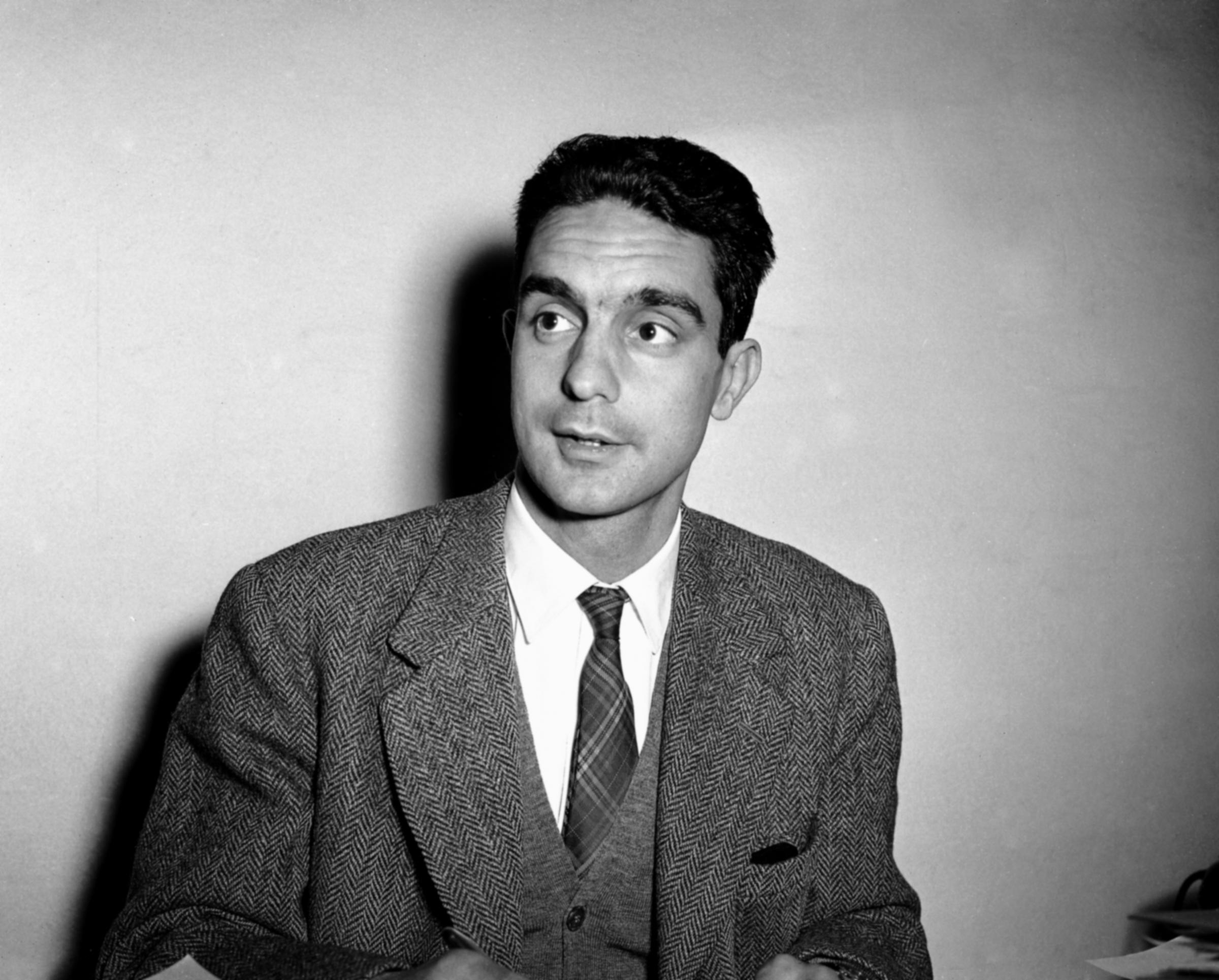 Bookavenue festeggia il 90mo compleanno di Italo Calvino con l’articolo di Antonio Capitano. Al grande autore, proprio per l’occasione, sono dedicate diverse manifestazioni nel nostro Paese.
Bookavenue festeggia il 90mo compleanno di Italo Calvino con l’articolo di Antonio Capitano. Al grande autore, proprio per l’occasione, sono dedicate diverse manifestazioni nel nostro Paese.