 “Un uomo di cultura è tale se sa guardare in modo non superficiale oltre il presente, sia verso il passato sia, per formulare congetture, ipotesi e decisioni – soprattutto se è uomo politico – , verso il futuro”.
“Un uomo di cultura è tale se sa guardare in modo non superficiale oltre il presente, sia verso il passato sia, per formulare congetture, ipotesi e decisioni – soprattutto se è uomo politico – , verso il futuro”.
Questa una delle tante frasi significative pronunciate nel corso della sua vita terrena dal sempre attuale Sylos Labini. Un pensiero civile, sconfinato, espresso sempre con vivacità e chiarezza utile a tratteggiare una parte importante della storia italiana. Capita quotidianamente di “incontrarlo” nelle pagine di un libro o di un quotidiano. Non c’è fatto socio economico che non ci riconduca alla sua azione di civil servant. Peraltro, l’aggettivo civile è stato uno dei più usati dal maestro per indicare una persona civile (si pensi alla descrizione del prezioso Ernesto Rossi) o a quella civiltà limitata in cui si era ridotto il nostro Paese visto con i suoi occhiali di osservatore acuto, attento e con la coscienza della persona per bene.
Podcast. I cento anni di Gil Evans
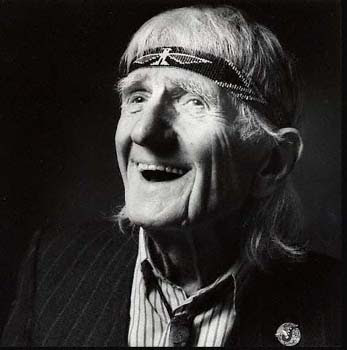 Ian Ernest Gilmor Green, detto Gil Evans, nato casualmente a Toronto, nel 1912. da padre sconosciuto e da una ragazza madre scozzese-irlandese (che girava il mondo come ragazza alla pari/governante), resta una delle figure più incomprese della storia del jazz. Largamente autodidatta, apparve all’improvviso sulla scena newyorchese del jazz nei primi anni quaranta, ma aveva alle spalle già una lunga attività di capo-orchestra e un mestiere affinato in duri anni di apprendistato in California, nel corso di una carriera che spesso e volentieri si era intersecata con quella di un suo celebre coetaneo Stan Keaton (che invece aveva esordito come pianista proprio in una delle orchestre di Evans).
Ian Ernest Gilmor Green, detto Gil Evans, nato casualmente a Toronto, nel 1912. da padre sconosciuto e da una ragazza madre scozzese-irlandese (che girava il mondo come ragazza alla pari/governante), resta una delle figure più incomprese della storia del jazz. Largamente autodidatta, apparve all’improvviso sulla scena newyorchese del jazz nei primi anni quaranta, ma aveva alle spalle già una lunga attività di capo-orchestra e un mestiere affinato in duri anni di apprendistato in California, nel corso di una carriera che spesso e volentieri si era intersecata con quella di un suo celebre coetaneo Stan Keaton (che invece aveva esordito come pianista proprio in una delle orchestre di Evans).
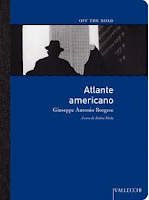
Un Atlante pieno di cose
 Si avverte qualcosa di grave e di sacro quando ci si trova nei pressi dello stretto di Gibilterra e si esce dal nostro mare chiuso per andare verso il mare aperto. Per Giuseppe Antonio Borgese, in viaggio per gli Stati Uniti nel 1931, è uno strano sentimento di separazione, una sorta di stacco potente, improvviso. “Si direbbe che più di quattro secoli dalla scoperta dell’America non abbiano demolito del tutto il sentimento della separazione, che l’unità del pianeta non sia ancora una conoscenza acquisita e tranquilla, e ognuno ancora quasi la debba conquistare o almeno profondarla dalla mente al cuore”. Chiunque navighi in queste acque prova un fremito possente, il fremito di chi vuol vivere ed espandersi.
Si avverte qualcosa di grave e di sacro quando ci si trova nei pressi dello stretto di Gibilterra e si esce dal nostro mare chiuso per andare verso il mare aperto. Per Giuseppe Antonio Borgese, in viaggio per gli Stati Uniti nel 1931, è uno strano sentimento di separazione, una sorta di stacco potente, improvviso. “Si direbbe che più di quattro secoli dalla scoperta dell’America non abbiano demolito del tutto il sentimento della separazione, che l’unità del pianeta non sia ancora una conoscenza acquisita e tranquilla, e ognuno ancora quasi la debba conquistare o almeno profondarla dalla mente al cuore”. Chiunque navighi in queste acque prova un fremito possente, il fremito di chi vuol vivere ed espandersi.
L’albero e la bambina
… L’albero era bellissimo e triste.
Sognava da sempre di volare e le radici lo tenevano stretto in un abbraccio perenne con la terra su cui tanti anni prima la cornacchia aveva lasciato cadere un seme secco.
Cosa avrebbe fatto per tornare indietro.
Sognava di convincere la cornacchia
a trattenere nel becco il seme
ancora e ancora …”Una bambina e un albero uniti da un sogno: volare in alto nel cielo…
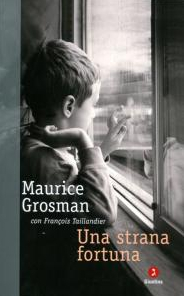
Una strana fortuna
 Per un pomeriggio intero, la madre di Maurice cuce con grande attenzione le stelle sui grembiuli di scuola. Si siede vicino alla finestra nell’unica stanza della loro casa e Maurice, coi suoi fratelli, la guarda lavorare con grande interesse.
Per un pomeriggio intero, la madre di Maurice cuce con grande attenzione le stelle sui grembiuli di scuola. Si siede vicino alla finestra nell’unica stanza della loro casa e Maurice, coi suoi fratelli, la guarda lavorare con grande interesse.
Cuce a piccoli punti serrati, precisi, uno dopo l’altro. Tutto quello che fa mia madre, pensa Maurice, lo cerca sempre di fare con tutto l’impegno e la cura che può.
Quelle stelle si era dovuto comprarle e si erano usati i “buoni per i tessili” che il Comune ormai distribuiva col contagocce. Bisogna comprarsele pagarsele e cucirsele da sé. E’ importante che le stelle siano cucite in modo solido. Si dice che una stella cucita male potrebbe procurare guai seri…
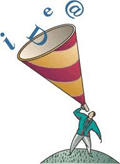
Il IX Rapporto Civita le citta’, le politiche culturali per una concreta strategia di sviluppo
 I centri urbani rappresentano un “banco di prova” importante per verificare le potenzialità dei processi di valorizzazione della Cultura, in termini di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, rafforzamento degli elementi di identità e coesione sociale in tempi in cui la crisi economica accresce le divisioni e i contrasti sociali con l’obiettivo dell’ incremento del potenziale “attrattivo” per un ritorno concreto in termini economici e di benessere anche oltre il concetto tradizionale di PIL. La Cultura, infatti, rappresenta per la Città un elemento imprescindibile di sviluppo e crescita perché, conferendole un elemento di specializzazione ed identità forte, la rende in grado di proteggersi dal pericolo della competitività e crearsi una rendita di posizione ben consolidata.
I centri urbani rappresentano un “banco di prova” importante per verificare le potenzialità dei processi di valorizzazione della Cultura, in termini di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, rafforzamento degli elementi di identità e coesione sociale in tempi in cui la crisi economica accresce le divisioni e i contrasti sociali con l’obiettivo dell’ incremento del potenziale “attrattivo” per un ritorno concreto in termini economici e di benessere anche oltre il concetto tradizionale di PIL. La Cultura, infatti, rappresenta per la Città un elemento imprescindibile di sviluppo e crescita perché, conferendole un elemento di specializzazione ed identità forte, la rende in grado di proteggersi dal pericolo della competitività e crearsi una rendita di posizione ben consolidata.
Podcast. La solitudine dell’eroe: Thelonius Monk
 Monk nacque a Rocky Mount (North Carolina) il 10 ottobre del 1917 in una famiglia modesta nella quale la musica era presente grazie alla madre cantante di gospel e spiritual nella chiesa locale; trasferitosi ben presto a New York, Monk iniziò fin da adolescente una vita “on the road” passata a suonare nei locali di stride-piano – i cui echi non lasceranno mai il suo pianismo – dove arricchisce il suo bagaglio musicale. Ciò diverrà fondamentale per la formazione della nuova “cosa” nascente in ambito jazzistico, ovvero il be-bop, che con Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Charlie Christian e Kenny Clarke egli contribuì a far nascere.
Monk nacque a Rocky Mount (North Carolina) il 10 ottobre del 1917 in una famiglia modesta nella quale la musica era presente grazie alla madre cantante di gospel e spiritual nella chiesa locale; trasferitosi ben presto a New York, Monk iniziò fin da adolescente una vita “on the road” passata a suonare nei locali di stride-piano – i cui echi non lasceranno mai il suo pianismo – dove arricchisce il suo bagaglio musicale. Ciò diverrà fondamentale per la formazione della nuova “cosa” nascente in ambito jazzistico, ovvero il be-bop, che con Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Charlie Christian e Kenny Clarke egli contribuì a far nascere.
Ma Monk non era un bopper, o almeno non era “solo” quello; l’adesione al famoso modo di dire dei bopper “io suono la mia musica e non mi interessa se ti piace o no” non era per Monk un atteggiarsi, ma qualcosa di naturale, semplicemente un modo per essere se stesso. E la sua storia musicale orgogliosamente autarchica lo dimostra apertamente.

La libertà, un traguardo verso cui tendere
. “Il disagio della Libertà” edito da Rizzoli è un piacevole pamplhet ricco di citazioni incastonate nelle piacevoli pagine, un “ponte” lungo novant’anni di storia, …
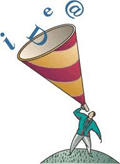
Salto in basso
 Cos’ è se vi pare. Il dado è tratto. Obtorto collo.
Cos’ è se vi pare. Il dado è tratto. Obtorto collo.
Mario Monti ha detto no. Le Olimpiadi a Roma non si faranno. Per la verità Monti non ha deciso di non fare le Olimpiadi, ma non ha firmato la “fidejussione” per garantire la candidatura di Roma. Ha fatto bene? Ha fatto male? Chissà. Il tempo aiuterà a capire le cose. Certo è che l’Italia non se la passa bene e l’esperienza consolidata di anni di sperperi e di opere incompiute, a fronte di stratosferici stanziamenti, avrà convinto il premier dell’austerity a non allargare la cinghia in questo momento di risparmio in ogni dove.
La “lotta greco- romana” non ha permesso di correre rischi. Un” salto triplo” nel buio non avrebbe permesso la “maratona” per arrivare a superare la selezione. Ora inizierà il “tiro a segno” sulle responsabilità con una “lotta libera” tra chi voleva le olimpiadi agendo con grinta da “pugilato” e tra chi non le voleva (con motivazioni evidenti) che risponderanno con la precisione tecnica della “scherma”.