 Riceviamo e volentieri pubblichiamo dal gruppo di lettura degli Amici del Libro di Montichiari
Riceviamo e volentieri pubblichiamo dal gruppo di lettura degli Amici del Libro di Montichiari
“Poche ore dopo la mezzanotte del 23 luglio 1957, Tomasi di Lampedusa moriva nel sonno.
Solo un anno prima, quando il mortale destino era ancora ignoto alle righe de Il Gattopardo e alla consapevolezza del suo autore, il principe di Lampedusa andava scrivendo il romanzo che l’avrebbe reso eterno. Non c’è da stupirsi che il primo approccio con lo scritto sia fallimentare, poiché è da studenti che generalmente se ne conosce l’essenza, nel vincolo di un dovere che ruba la bellezza a una memorabile prosa, da qualcuno definita “d’arte”. Il fascino dell’opera si svela poi negli anni, quando scorrendo lo sguardo sopra una fila di vecchi libri, si torna a leggerlo. E Il Gattopardo, tanto per intenderci, «è uno di quei romanzi nei quali, anche quando la macchina del racconto sembra incepparsi o rallentare di ritmo, c’è sempre almeno un motore di riserva che funziona» (Geno Pampaloni)

 Una fiaba sudanese narra di quattro animali – un leone, una iena, un serpente e un ghepardo – che un tempo dividevano una capanna in un piccolo villaggio. Vivevano in perfetta armonia, finché non decisero che avevano bisogno di regole per garantire un maggiore rispetto reciproco. Così fecero una riunione in cui si chiese a ciascuno di illustrare agli altri i propri desideri.
Una fiaba sudanese narra di quattro animali – un leone, una iena, un serpente e un ghepardo – che un tempo dividevano una capanna in un piccolo villaggio. Vivevano in perfetta armonia, finché non decisero che avevano bisogno di regole per garantire un maggiore rispetto reciproco. Così fecero una riunione in cui si chiese a ciascuno di illustrare agli altri i propri desideri. Può uno cui «vengono bene» le rapine provare solidarietà verso gli sfruttati? Può, uno che vede e percepisce le innumerevoli ingiustizie del mondo, fare il criminale? A leggere il romanzo di Massimiliano Smeriglio («Garbatella combat zone», edito da Voland) parrebbe di sì. Del resto, per capire di cosa stiamo parlando citiamo una riga, suprema chiave interpretativa della fatica dell’autore che compare a pagina 136: «Il tema delle coerenza lo svolgeva su un canovaccio tutto suo, incomprensibile ai più». L’incoerenza, dunque, come dramma esistenziale: è questo il tema dominante di un romanzo difficile da dimenticare.
Può uno cui «vengono bene» le rapine provare solidarietà verso gli sfruttati? Può, uno che vede e percepisce le innumerevoli ingiustizie del mondo, fare il criminale? A leggere il romanzo di Massimiliano Smeriglio («Garbatella combat zone», edito da Voland) parrebbe di sì. Del resto, per capire di cosa stiamo parlando citiamo una riga, suprema chiave interpretativa della fatica dell’autore che compare a pagina 136: «Il tema delle coerenza lo svolgeva su un canovaccio tutto suo, incomprensibile ai più». L’incoerenza, dunque, come dramma esistenziale: è questo il tema dominante di un romanzo difficile da dimenticare.
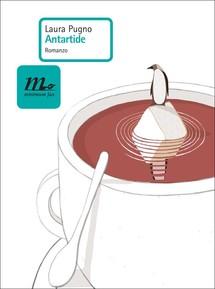

 Libro del mese / Settembre. Questo librino di Lodovico Terzi, pubblicato da Einaudi all’inizio dell’estate, vale tutti i libri-furbi di Pansa. È un magnifico memoir che narra i “due anni senza gloria” di un ragazzo borghese arruolato nella RSI e del conflitto personale e famigliare che lo costringe a una maturazione civile e politica. Non mi meraviglia che un libro così difficile e onesto non sia stato candidato in alcun premio letterario.
Libro del mese / Settembre. Questo librino di Lodovico Terzi, pubblicato da Einaudi all’inizio dell’estate, vale tutti i libri-furbi di Pansa. È un magnifico memoir che narra i “due anni senza gloria” di un ragazzo borghese arruolato nella RSI e del conflitto personale e famigliare che lo costringe a una maturazione civile e politica. Non mi meraviglia che un libro così difficile e onesto non sia stato candidato in alcun premio letterario.

 I romanzi dedicati ai propri cari lasciano sempre uno strascico di sofferenza, probabilmente per quel grado di immedesimazione possibile da cui difficilmente si sfugge. Gli autori, oppure i narratori (a seconda dei casi), tentano forse di offrire in memoria una parte di sé inconfessabile o semplicemente desiderano liberarsi da qualcosa o qualcuno troppo vicino, carne della propria carne. Si tratta di una riabilitazione postuma del proprio stato di genitore o di figlio, oppure di una rivendicazione, come nel caso di Kafka che scrisse nel 1919 una lunga lettera al padre, pubblicata senza cercare una comunicazione diretta, e quindi una risoluzione rassicurante. Si rivolge al genitore di cui ha sempre avuto terrore, che teme e adora come si fa per i carnefici talvolta, quando non si hanno altre vie di fuga.
I romanzi dedicati ai propri cari lasciano sempre uno strascico di sofferenza, probabilmente per quel grado di immedesimazione possibile da cui difficilmente si sfugge. Gli autori, oppure i narratori (a seconda dei casi), tentano forse di offrire in memoria una parte di sé inconfessabile o semplicemente desiderano liberarsi da qualcosa o qualcuno troppo vicino, carne della propria carne. Si tratta di una riabilitazione postuma del proprio stato di genitore o di figlio, oppure di una rivendicazione, come nel caso di Kafka che scrisse nel 1919 una lunga lettera al padre, pubblicata senza cercare una comunicazione diretta, e quindi una risoluzione rassicurante. Si rivolge al genitore di cui ha sempre avuto terrore, che teme e adora come si fa per i carnefici talvolta, quando non si hanno altre vie di fuga. L’appartamento era piccolo, buio, soffocante; odorava di polvere, di vecchie stoffe; i soffitti bassi sembravano pesare sulla testa; dalle finestre si vedeva il cortile, lungo e stretto, con i muri imbiancati a calce che riflettevano spietatamente il sole di luglio. Fin dal mattino venivano chiuse imposte e finestre, e in quelle quattro stanzette buie i Karin vivacchiavano fino a sera, senza uscire, sconcertati dai rumori di Parigi, respirando con fastidio il tanfo degli scarichi e delle cucine che saliva dal cortile. Camminavano avanti e indietro da una parete all’altra, in silenzio, come le mosche d’autunno, allorché, passati il caldo e la luce dell’estate, svolazzano a fatica, esauste e irritate, sbattendo contro i vetri e trascinando le ali senza vita.
L’appartamento era piccolo, buio, soffocante; odorava di polvere, di vecchie stoffe; i soffitti bassi sembravano pesare sulla testa; dalle finestre si vedeva il cortile, lungo e stretto, con i muri imbiancati a calce che riflettevano spietatamente il sole di luglio. Fin dal mattino venivano chiuse imposte e finestre, e in quelle quattro stanzette buie i Karin vivacchiavano fino a sera, senza uscire, sconcertati dai rumori di Parigi, respirando con fastidio il tanfo degli scarichi e delle cucine che saliva dal cortile. Camminavano avanti e indietro da una parete all’altra, in silenzio, come le mosche d’autunno, allorché, passati il caldo e la luce dell’estate, svolazzano a fatica, esauste e irritate, sbattendo contro i vetri e trascinando le ali senza vita. “Io sono il legame tra il cielo e la terra. Io sono il cielo e la terra, il padre e la madre. L’essenza stessa del cosmo”.
“Io sono il legame tra il cielo e la terra. Io sono il cielo e la terra, il padre e la madre. L’essenza stessa del cosmo”.